
Se vorrai lasciare un commento ci farà piacere. Buona lettura.
Il 3 marzo 2021 scompare una ragazza nel quartiere londinese di Clapham Common. Il suo nome era Sarah Everard.
Non che sia rilevante dirlo, ma Sarah stava rientrando alle 21.30 dopo una serata trascorsa a casa di un’amica. Si stava dirigendo verso casa sua scegliendo la strada più lunga ma più illuminata. Indossava abiti comodi e colorati, delle scarpe da ginnastica e un impermeabile verde. Aveva anche chiamato brevemente il fidanzato lungo il tragitto per avvisarlo che si stava incamminando. Non è mai arrivata a casa.
Il giorno dopo il fidanzato ne denuncia la scomparsa e partono le ricerche.
Il 9 marzo viene arrestato un poliziotto, Wayne Couzen, sospettato di aver rapito la ragazza.
Il 10 marzo Scotland Yard dichiara di aver trovato dei resti umani in un bosco nel Kent. Sono i resti di Sarah in un borsone, talmente irriconoscibili che la sua identificazione è stata possibile solo grazie ad un esame dentale. Sarah è stata seviziata e fatta a pezzi da Couzen che viene accusato di rapimento e omicidio.
Fin qui, a ben vedere, sembra purtroppo uno dei tanti casi di femminicidio all’ordine del giorno: una ragazza cammina da sola per strada di notte e viene aggredita.
Nulla di nuovo se si considera che l’OMS ha da poco riportato che 1 donna su 3 nel mondo è stata soggetta ad abuso fisico o sessuale almeno una volta nella vita. Inoltre, appena una settimana prima del rapimento di Sarah, il Guardian aveva pubblicato i risultati di un sondaggio di UN Women UK sulle molestie sessuali verso le donne inglesi. UN Women definisce le molestie come condotte sessuali indesiderate: si va dallo stupro ad altre aggressioni fisiche, dalla condivisione senza consenso di fotografie intime alle molestie verbali a sfondo sessuale. Il 97% delle donne tra i 18 e 24 anni nel Regno Unito ha dichiarato di aver subito molestie sessuali, mentre l’80% di quelle di tutte le età è stata molestata in luoghi pubblici. La pervasività degli abusi è data per scontata al punto che il 98% delle ragazze non denuncia ed è certa che non servirebbe a nulla.
Come ha dichiarato l’onorevole Jess Philips al Parlamento Inglese: “Le donne morte sono una cosa che abbiamo semplicemente accettato come parte delle nostre vite quotidiane. Le donne uccise non sono estremamente rare. Che le donne vengano uccise è una cosa comune”.
Ovviamente questa triste normalità non si ferma solo all’Inghilterra.
Stando ad una ricerca dell’Istat del 2014, il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale. Il 24,7% delle donne ha subito una violenza perpetrata da uomini non partner: conoscenti, amici, parenti e colleghi di lavoro.
Una percentuale non trascurabile riguarda anche lo stalking, subito dal 21,5% delle donne tra i 16 e 70 anni da parte di un ex partner. Ma i casi di stalking da parte di sconosciuti si attestano al 10,3%.
Recenti sono invece i dati sul femminicidio in Italia: dall’inizio dell’anno ce n’è stato 1 ogni 5 giorni e il 2020 è stato l’anno peggiore da vent’anni a questa parte: durante la pandemia, infatti, i femminicidi sono stati il 45% del totale degli omicidi. Inoltre, se negli ultimi 25 anni il numero di omicidi ai danni di uomini è sensibilmente diminuito, quello dei femminicidi è rimasto pressoché stabile.
In questi giorni anche in Australia si dibatte molto di violenza di genere a causa di alcuni scandali che hanno coinvolto membri del Parlamento. Dando un’occhiata ai numeri pubblicati nel 2015 dal loro istituto di statistica, si evince che un terzo di tutte le donne australiane sono state aggredite fisicamente e un quinto di tutte le donne aveva subito molestie sessuali nell’anno precedente.
Insomma, sembra proprio che il caso di Sarah sia solo uno dei tanti. Eppure stavolta è successo qualcosa.
Dopo il ritrovamento del corpo, il 13 marzo a Clapham Common viene organizzata una veglia per Sarah che raccoglie centinaia di partecipanti. La veglia non era stata autorizzata per via della pandemia e la polizia interviene in maniera “inappropriata e sproporzionata”, a detta dello stesso sindaco, disperdendo la folla con violenza e distruggendo il memoriale di fiori e biglietti per Sarah. Si verificano anche 4 arresti.
Il giorno dopo, un corteo di più di mille persone scende in strada in segno di protesta davanti a Scotland Yard.
A tutto ciò si aggiunge che, durante le indagini, la polizia aveva suggerito alle donne di non uscire da sole la sera.
In risposta, la politica Jenny Jones ha dichiarato alla Camera dei Lord che bisognerebbe piuttosto imporre un coprifuoco agli uomini per far stare al sicuro le donne.
Le sue parole, ovviamente provocatorie, hanno sollevato un polverone di reazioni maschili offese e contrariate. La replica della Jones è stata tesa a puntualizzare come avesse voluto rendere evidente l’uso di due pesi e due misure: nessuno ha battuto ciglio quando è stato suggerito alle donne di limitare la propria libertà per proteggersi da un comportamento maschile, ma la stessa richiesta è stata ritenuta offensiva se proposta agli uomini.
“Chi insorge all’idea di un coprifuoco maschile forse dovrebbe chiedersi, con un po’ di spirito critico, perché non ci si arrabbia allo stesso modo quando alle donne viene detto di adattare il loro comportamento in risposta alla violenza maschile”, scrive Arwa Mahdawi sul Guardian, aggiungendo che, sebbene le donne non debbano rispettare un coprifuoco legale, la loro libertà di movimento non è comunque piena.
Sin da piccole, le donne vengono messe in guardia sulla necessità di proteggersi e limitare i propri comportamenti, valutando accuratamente i rischi che i loro spostamenti o atteggiamenti possono comportare. È ormai una valutazione automatica che ognuna di noi fa: come vestirci, quanto bere, che strada scegliere, che mezzo prendere, quando rientrare, con chi, ecc. Tutto questo in virtù della sensazione di essere più al sicuro (anche dal victimg blaming: l’accusa che la vittima abbia contribuito a creare o ritrovarsi in una situazione di rischio. In gergo comune: “Se l’è cercata”).
Uno degli elementi, infatti, che ha senz’altro contribuito a creare grossa risonanza sul caso di Sarah è che la ragazza sembrava aver valutato molto bene tutte le fonti di rischio, cercando di ridurle. Ha scelto vestiti sportivi e non succinti, scarpe comode con cui avrebbe potuto correre all’occorrenza e non tacchi, ha scelto la via più sicura, anche se più lunga, perché meglio illuminata e più frequentata, ha chiamato il ragazzo per dargli conto dei suoi spostamenti. Insomma, ha fatto tutto giusto anche per ripararsi da un ipotetico victim blaming (che è comunque arrivato dal consiglio della polizia). Ma non è bastato ugualmente a proteggerla.
L’insieme di tutte queste vicende ha sollevato una discussione in tutto in paese, sui social per lo più, che ha portato alla luce le esperienze di moltissime donne nella vita di tutti i giorni e il loro senso di paura e allarme nel camminare per strada da sole.
Un tweet nel quale si chiedeva alle donne se avessero mai finto una telefonata, cambiato strada o corso in preda alla paura dopo essersi sentite spaventate nell’essere sole in strada con un uomo, è stato retwittato più di 120mila volte. A questo, si sono aggiunti racconti sull’essere state seguite, molestate, assalite o aver subito catcalling (un tipo di molestia che consiste nel rivolgere apprezzamenti e appellativi a sfondo sessuale a donne sconosciute che si incrociano per strada) e sulle strategie più comuni che vengono adottate per sentirsi al sicuro. Oltre a fingere di chiamare qualcuno o farlo davvero e cambiare strada, le più comuni sono: moderare il proprio abbigliamento, infilare i capelli lunghi nella giacca, non mettere le cuffiette mentre si fa jogging, tenere il numero della polizia pronto alla chiamata, scegliere strade illuminate e ben frequentate, ecc. La sensazione ridondante è che tutto questo sia estenuante, oltreché ingiusto, perché, benché le donne non abbiano colpa alcuna, si richiede loro da sempre di limitare le proprie libertà per proteggersi.
Secondo Kate Manne, esperta di sessismo e società, “le libertà delle donne vengono viste come superflue, usa e getta – come spesso talvolta vengono tragicamente viste le donne stesse. Si assume automaticamente che dato che la vita degli uomini non è influenzata in modo significativo da questo fenomeno, non gli si possano chiedere grandi sacrifici per cambiare le cose”.
Col caso di Sarah è emerso con chiarezza come la narrazione intorno alla questione della sicurezza delle donne debba cambiare prospettiva perché sembra che le donne non siano più disposte a subirne tutto il peso. L’hashtag che rimbalza a tal proposito è #ReclaimTheseStreets (Riprendiamoci queste strade), accompagnato da #IamSarah.
Quello che i movimenti femministi cercano di mettere in luce è che non ci si occupa della violenza contro le donne da un punto di vista strutturale, ma solo securitario. La femminista Julie Bindel spiega che in questo modo si perpetua una “mitologia dannosa”, cioè si trasmette che le donne “sono in qualche modo complici se sono fuori e da sole, la notte; e che quella notte è il pericolo, non gli uomini responsabili”. In questo modo non si fa che istruire una nuova generazione di donne a mettersi in sicurezza limitando la propria libertà.
Eppure, il governo britannico sta varando una legge sulla violenza di genere che mira proprio a misure securitarie come aumentare i fondi per sorvegliare e illuminare le strade, aumentare la presenza di poliziotti in borghese nei locali. Anche in Italia gli interventi governativi seguono spesso questi approcci.
La critica dei movimenti femministi, come Sisters Uncut, è che queste risposte non prendono di nuovo in considerazione gli autori del reato ma solo la protezione della vittima. Quel che chiedono, invece, sono interventi strutturali per affrontare la violenza maschile al di là dell’emergenza e della sicurezza: sostenere le donne che hanno subito abusi, migliorare l’iter di segnalazione e denuncia, investire nelle case rifugio, migliorare l’assistenza sociale, sanitaria e giudiziaria e cominciare da un’adeguata educazione sessuale ed affettiva nelle scuole.
Insomma, le donne stanno ribaltando la domanda di fondo. Come scrive la giornalista Ali Pentony: “Perché stiamo ancora parlando di cosa possono fare le donne per stare al sicuro e non di cosa possono fare gli uomini per smettere di minacciare la nostra sicurezza? (…) Se continuiamo a dire alle donne di conformare le loro azioni per rimanere al sicuro, non stiamo affrontando il problema. Non stiamo risolvendo nulla. Stiamo solo trasmettendo il senso di pericolo a un’altra donna.”
Il problema non viene dalle donne, dunque qual è stata la risposta degli uomini?
Il tweet di un ragazzo che chiedeva cosa potessero fare concretamente gli uomini per ridurre il senso di ansia e paura, ha ricevuto più di 27mila likes e ha dato il via ad alcuni suggerimenti pratici. Il più ripetuto è quello di cambiare lato del marciapiede quando ci si accorge di camminare dietro una ragazza sola in una via isolata e lasciarle più distanza possibile.
Insieme alle proposte maschili di collaborazione e aiuto per migliorare la situazione, però, sono arrivate anche tante risposte che ripercorrono il filone dell’offesa. Questo filone, riassumibile sotto l’hashtag #NotAllMen (Non tutti gli uomini), sottolinea il fatto che solo una minoranza di uomini sono aggressori e, dunque, quelli che non lo sono non dovrebbero modificare il proprio comportamento limitando la propria libertà ed è offensivo chiederglielo.
Benché l’idea che sostiene l’obiezione #NotAllMen sia senz’altro veritiera (non tutti gli uomini sono aggressori), questa porta sostanzialmente a spostare il focus.
Provando a fare un parallelismo, se una persona ci dice di esser stata investita da qualcuno che usava il cellulare alla guida, la nostra prima reazione spontanea è probabilmente chiederle come sta ed esprimere sincera preoccupazione per la sua salute. Difficilmente sarà premurarci di mettere in chiaro, in prima battuta, che noi non usiamo il telefono alla guida! Perché invece di prenderci cura della persona che abbiamo davanti e della sua esperienza, sposteremmo l’attenzione sulla nostra coscienza e la necessità di sentirci assolti.
Rispondere che non tutti gli uomini sono così, ad una ragazza che sta raccontando la propria esperienza di molestie o abuso, significa esattamente spostare il focus dalla vittima a sé stessi. L’impulso è difendersi da un’accusa (che nessuno ha mosso in realtà), perdendo l’occasione di dare voce al dolore di quella donna, di ascoltare il suo vissuto, prenderlo in considerazione ed, infine, attivare un pensiero critico che possa portare a chiedersi se si può far qualcosa per migliorare la situazione.
Con le parole di Irene Facheris, attivista e creatrice di “Parità in pillole”: “Gli uomini decenti quando vengono messi di fronte a un problema, si chiedono se hanno fatto qualcosa per alimentarlo e se possono fare qualcosa per eliminarlo. Spostare l’attenzione dalla vittima a te e alla tua categoria, che senti di dover difendere senza che ci sia stata un’accusa (…), ti rende parte del problema” (…) “Quando diciamo che le statistiche sono terrificanti e che ci sono troppi uomini che agiscono in un certo modo, in che modo dire “Ma non tutti!” aiuta a gestire il problema?” (…) “Riguarda tutti gli uomini perché ogni uomo può fare qualcosa dal momento in cui diventa consapevole di questi meccanismi” (…) “Tutti gli uomini hanno la responsabilità di educarsi, di capire quanto sessismo abbiano assorbito e come questo si manifesti. Non è una guerra uomini vs donne. Proviamo a fare qualcosa di più utile e a farlo insieme”.
Il concetto è stato approfondito anche da Attilio Palmieri, critico televisivo e femminista, che incalza: “Una generalizzazione è l’estensione di qualcosa a un’intera categoria. Un’operazione legittima se ci sono i presupposti.” (…) “Quindi, quando si dice che a uccidere le donne per il solo fatto di esistere come donne nel mondo sono gli uomini, si dice una cosa incontestabile.” (…) “La corsa tempestiva a difendere la propria categoria da parte di così tanti maschi è la dimostrazione di connivenza e disinteresse a cambiare davvero le cose. È il simbolo di una totale indifferenza alla violenza di genere, tanto da mettere per l’ennesima volta al centro del discorso se stessi. (…) Con il nostro silenzio abbiamo la possibilità di lasciare spazio alle voci delle donne, sia di farci due domande sul perché oggi uno spazio safe è di default uno spazio senza maschi, perché il problema siamo noi e non chi ce lo fa notare”.
Rappresentativo in tal senso è quanto successo a Repubblica quando, nel Novembre 2020, ha pubblicato un post titolando “La gelosia non uccide, gli uomini sì”. Dopo la valanga di critiche maschili ricevute, il giornale ha modificato in “La gelosia non uccide, alcuni uomini sì”, chiosando: “La storica discriminazione nei confronti delle donne ci impone una maggiore attenzione nei confronti del femminicidio, in cui la vittima è colpevolizzata in quanto donna. Questo non significa che tutti gli uomini siano assassini, ovviamente. Ma non possiamo nemmeno trascurare la matrice patriarcale di questa specifica categoria di omicidi”. Inutile dire che siccome il dibattito si è acceso su questioni di “forma”, si è persa l’occasione di focalizzarsi sul problema lasciando più sole che mai le vittime alle quali si stava cercando di dare spazio. Sostanzialmente il senso del post è diventato nullo.
Accanto al filone #NotAllMen, ce n’è un altro che invece rifiuta completamente l’idea di doversi prendere carico di un allarmismo ritenuto infondato.
Questo emerge, ad esempio, da quanto si è verificato in Italia quando la pagina social FanPage (1,5 milioni di follower) ha pubblicato un post, derivato dal Guardian, con una carrellata di consigli scritti da donne su come aiutarle a sentirsi più al sicuro. Il primo recitava: “Cambia marciapiede. Camminare per strada e percepire la presenza di un uomo alle proprie spalle può provocare ansia e panico”. Anche questo post ha suscitato una valanga di commenti maschili contrari ed è stato cancellato quasi subito.
La ruota dei commenti rende bene l’idea di quanto la questione venga percepita come frutto di una “labilità emotiva” femminile: donne troppo spaventate ed eccessivamente ansiose oppure troppo arrabbiate e rancorose con tutti gli uomini. I commenti sono per lo più sarcastici sull’assurdità della “pretesa” e sul proliferare di un “nazifemminismo” che arriverà a limitare ogni comportamento maschile.
Da tutto ciò arriva chiaramente che è molto difficile far comprendere quel senso di allarme e di continuo monitoraggio di sé stesse a chi non è stato socializzato a guardarsene e non l’ha mai sperimentato.
A tal proposito, il tweet virale di @fayesos dice:
“Se non hai …
– scritto a un amico/a “Sono a casa”
– attraversato una strada per evitare qualcuno
– chiamato e detto “parla con me per 5 minuti”
– annotato la targa di un taxi / auto
– tirato fuori le chiavi per esser pronta
– chiuso subito la portiera della macchina
– trattenuto il respiro finché non hai superato qualcuno
… allora sei un uomo”
Insieme a questa voce, ha avuto risonanza anche quella di Grace Jessup, una ragazza di 31 anni che aggiunge: “Ho imparato fin dalla tenera età che avrei dovuto cambiare il mio comportamento per mantenermi al sicuro e ora stiamo vedendo che molte donne cominciano a dire quanto sono stufe di questa situazione. Siamo anche un po’ stufe del fatto che questo sia uno shock per gli uomini. Questa è la mia realtà da quando avevo circa 14 anni!”
Il ministro inglese Victoria Atkins ha commentato: “Penso che le esperienze che le donne hanno condiviso sui social siano assolutamente scioccanti. E penso che gli uomini non abbiano ancora realizzato ciò che attraversano le donne a loro care, le loro sorelle, le loro ragazze, le loro mogli. Credo davvero che questo possa essere un momento di cambiamento”.
Tutto questo evidenzia che c’è un problema di comunicazione e comprensione empatica tra i due mondi. E vi è, anche, una sottostima di quanto episodi di molestie di varia gravità portino con sé uno strascico psicologico di ansia, umiliazione e paura non indifferente. Chi subisce una molestia di strada, ad esempio, spesso modifica il proprio comportamento, limita le proprie uscite fino anche a cambiare quartiere. Inoltre, l’aver subito molestie correla con aumentati livelli di ansia, depressione e perdita della qualità del sonno. Infine, nelle vittime aumenta la tendenza a preoccuparsi e vergognarsi del proprio corpo. L’Istat ci dice che tra le donne che hanno subito molestie, solo la metà dichiara di aver superato l’episodio. “Molte riscontrano una maggiore difficoltà relazionale, la paura dei luoghi isolati e del buio, la perdita di fiducia negli uomini, nonché depressione, ansia o shock. Invece un residuale 4,2% dichiara di sentirsi più forte”.
Dovrebbe far riflettere su quanto impatto possa avere sulla vita di una donna quella che, spesse volte, viene sminuita come una “goliardata” maschile.
A tal proposito, un articolo di Time del 2014 descriveva una sorta di “scala di sviluppo” che gli uomini devono percorrere per arrivare ad una piena coscienza sociale rispetto alla violenza di genere.
Semplificando, la si può riassumere in 5 stadi di pensiero con livelli di consapevolezza crescenti:
- Il sessismo è una falsità inventata dalle femministe
- Il sessismo esiste, ma gli effetti del sessismo al contrario (contro gli uomini) sono uguali o peggiori
- Il sessismo esiste, ma io personalmente non sono sessista
- Il sessismo esiste e io ne traggo beneficio involontariamente, indipendentemente dal fatto di essere sessista o meno
- Il sessismo esiste, io ne traggo beneficio, certe volte sono sessista senza nemmeno rendermene conto perché sono stato socializzato in questo modo, e se voglio non esserlo più devo lavorare attivamente contro questa socializzazione.
Nel caso di Repubblica, la discussione online si è fermata per lo più allo stadio 3: #NotAllMen. Ma nel caso di FanPage, i commenti appartengono allo stadio 1 e 2.
Il caso Sarah Everard e l’esausta indignazione delle donne, stanno chiedendo agli uomini di fare dei passi verso gli stadi 4 e 5 e lavorare tutti insieme per socializzarci al rispetto e alla collaborazione tra sessi.
Da psicoterapeuta, penso sempre che il cambiamento passi dall’empatia. Se ci fermiamo ad ascoltare le storie degli altri, possiamo andare oltre le nostre categorie mentali e i nostri preconcetti, perché la verità che gli altri ci portano ci colpisce emotivamente e questo attiva una risonanza in noi. Da quella risonanza possiamo poi fare un percorso a ritroso, fino a tornare ad astrarci dall’emozione e passare di nuovo al pensiero. Ma ci arriveremo trasformati, se non altro perché avremo preso in considerazione anche un altro punto di vista.
È quello che la nostra società ha iniziato a mettere in atto, seppur lentamente, anche rispetto al razzismo, all’omofobia ed altre discriminazioni. Una volta che ci apriamo alle storie degli altri e comprendiamo il loro punto di vista, possiamo imparare a revisionare il nostro e, soprattutto, possiamo aiutare altri a considerare i limiti di una visione parziale.
Quindi il primo passo verso i punti 4 e 5 potrebbe essere quello di ASCOLTARE le donne che condividono le loro storie, senza biasimarle o zittirle e senza spostare il focus.
Per cominciare, la cosa più semplice che gli uomini possono fare è chiedere alle loro sorelle, fidanzate, madri e amiche di raccontare se e quando si sono sentite in pericolo a causa di un uomo: cos’è successo, cosa hanno provato o provano tutt’ora e se attuano degli stratagemmi per sentirsi più al sicuro ogni giorno. È un primo passo molto valido per approcciarsi al problema e capirne la portata e lo strascico emotivo.
Poi si potrebbe IMPARARE di più rispetto al problema, informandosi e leggendo più punti vista.
Si potrebbe RIFLETTERE sul proprio comportamento e chiedersi se, involontariamente, abbiamo fatto nostre delle visioni e dei pensieri che non sono innocui come sembrano. Riconoscerli è il primo passo per provare a cambiare.
Si potrebbe INSEGNARE ai nostri figli cosa sono l’abuso e il consenso e smettere di insegnare alle nostre figlie a limitare la propria libertà.
Si potrebbe ITERVENIRE quando si assiste a molestie ed eventi quali: fischiare, gridare oscenità, dare appellativi sessualizzanti, fissare in modo insistente e inappropriato, fotografare o filmare senza consenso e diffondere il materiale, seguire, masturbarsi in pubblico, palpeggiare, strusciarsi, assalire, stuprare, uccidere, ecc.
Il biasimo sociale è un potentissimo meccanismo che porta il gruppo a condannare o escludere chi indulge in un comportamento che non è socialmente accettabile. Dunque, un altro passo verso il cambiamento sarebbe non considerare più accettabile uno qualsiasi di questi comportamenti sessisti e violenti, facendo sì che le persone che li perpetrano si sentano esposte ed isolate e non più spalleggiate.
Nel mio piccolo, per partire dall’ascolto, ho chiesto alle ragazze intorno a me di raccontarmi i loro episodi di molestie e paura ed ho aggiunto i miei. Non mi ha stupita, ahimè, scoprire che nel mio campione non rappresentativo, sono state pochissime quelle che non avevano storie da segnalarmi. Mi ha colpito molto, però, che tutte fossero contente di potersi raccontare e abbiano voluto ringraziarmi per averne parlato, come in un abbraccio collettivo in memoria di Sarah.
Concludo riportando alcune delle loro storie, sperando che possano accendere l’empatia e il cambiamento anche solo in un lettore.
“Qualche anno fa ho riaccompagnato in stazione una mia amica che era venuta a trovarmi a Torino. Il suo treno era in prima serata, per le 21 massimo, la accompagno e la saluto affettuosamente dal binario mentre il suo treno parte e così mi avvio verso l’uscita per prendere il bus che mi avrebbe portata a casa. La stazione è praticamente vuota. Questo già un po’ mi inquieta ma cerco di non pensarci. Nell’ultima parte del mio percorso in stazione, vedo una persona seduta a terra: ho subito pensato ad un clochard. Vado avanti mantenendo il passo veloce. Non saprei spiegare bene come, ma di colpo mi ritrovo questo uomo in piedi che si avvia sempre più verso di me…vuole dirmi o chiedermi qualcosa ma nel mentre barcolla anche. Ora sì che ho paura perché tutto ciò avviene in un corridoio stretto e sento di non aver molte vie d’uscita. Mi irrigidisco mentre lui inizia con battutine del tipo – Che ci fai sola soletta qui? – o – Posso venire con te? -. Realizzo che non si tratta di una richiesta di aiuto e questo mi “tranquillizza” e spaventa allo stesso tempo, mi sento in allarme e mi guardo attorno ma non c’è nessuno. Per fortuna non riesce ad avere un contatto fisico con la mano perché faccio in tempo a divincolarmi e fuggire via… ma è stata una bruttissima esperienza, sapersi da sole e in balia di uno sconosciuto. Inevitabile non chiedersi – Cosa sarebbe potuto succedere se…-. Da allora appena sento di essere in una situazione ambigua, prendo il telefono e chiamo qualcuno, a volte ho anche cambiato strada, ma effettivamente tutto ciò non mi solleva o rincuora. Tutti e tutte noi dovremmo poter avere il coraggio di camminare tranquille, ovunque”. M., 31 anni
“Ero in un club di Latino americano dove vado a ballare salsa/bachata. La maggior parte delle persone che lo frequentano partecipano anche al corso e quindi le conosco, ma a volte ci sono persone nuove. Quella sera c’erano due ragazzi che non conoscevo e uno dei due mi aveva chiesto di ballare una canzone, ma scopro ben presto che non sa assolutamente ballare bachata e la sua idea di ballo è puramente strusciarsi. Io sono un sacco a disagio però penso – E’ una canzone e poi me ne libero -, ma il suo amico inizia a filmarci con il suo telefono. Se ci ripenso mi incazzo anche con me stessa perché avrei dovuto dire qualcosa, ma non volevo causare una scena e ho detto – Amen -. Finalmente finisce la canzone e io ballo solo più con persone che conosco e cerco di evitarli ma continuano a seguirmi e starmi appresso. Questo club ha due piani, allora prendo la mia amica e andiamo al piano di sotto ma questi ci seguono e cercano sempre di mettersi dietro di me mentre ballo. Per fortuna vedo un gruppo di miei amici e mi metto in mezzo a loro e finalmente, dopo un po’, i due ci rinunciano. Passa un bel po’ di tempo e io e la mia amica usciamo per tornare a casa. Allo stesso tempo anche i nostri amici escono e si accorgono che quei due sembravano seguirci quindi ci fermano e stanno con noi finché quelli non se ne vanno. Mi sono sentita sicuramente molto a disagio e un po’ violata, venire filmata è stata la ciliegina sulla torta. Però anche un po’ impotente, non so bene in che altri modi avrei potuto reagire, continuavano a chiedermi di ballare e continuavo a dire di no ma ignoravano totalmente il mio disagio”. A. 22 anni.
“Qualche anno fa io e mia cugina siamo andate a fare una passeggiata per Torino e di punto in bianco ci siamo accorte che un signore ci stava seguendo. Per strada c’era poca gente, ci siamo spaventate e abbiamo provato a seminarlo cambiando percorso. Il signore però continuava a seguirci e alla fine, a furia di cambiare strada, avevamo anche perso il senso dell’orientamento. Nonostante il timore, abbiamo azzardato e ci siamo fermate (con lui sempre dietro) tirando fuori il telefono e facendogli vedere che stavamo chiamando aiuto. A quel punto fortunatamente il signore è scappato e nostro zio è subito venuto a prenderci! Lo spavento è stato davvero traumatico. Ancora oggi ne parliamo”. M., 22 anni
“- Sin da quando ero adolescente prendevo il treno tutti i giorni, andata e ritorno, per raggiungere un paesino della cintura di Torino in cui studiavo danza. Un giorno estivo, sulla via del rientro, sono salita su un vagone quasi vuoto: c’erano solo una signora e un signore. Prendo posto in uno di quegli spazi composti da 4 sedili, apro il libro dell’università che stavo studiando e attendo che il treno riparta. Sento gli occhi del signore su di me, inizio a percepire il forte odore di alcool che emana. Continuo a leggere, ignoro. Lui inizia a parlare, fa dei commenti volgari, cerca di attirare la mia attenzione. Impassibile continuo a leggere, ma il mio cuore batte veloce. Ho paura. Inizio a pensare che non ci sono tante persone, guardo le vie di fuga. Sento il deserto intorno a me. Il signore si alza e si siede davanti a me. Io leggo. Mi formicola tutto, la paura è intensa. L’uomo mi parla, poi di getta su di me per baciarmi. Con rapidità e maestria mi ritrovo in piedi. Salva. Non mi ha sfiorato. Lui bofonchia, ride di me. Con il terrore addosso vado a sedermi di fronte alla signora. Tremo, non mi accorgo che il libro che ormai fingo di leggere è al contrario. Lei non dice una parola, a stento mi guarda e io con gli occhi imploro comprensione. Nulla. Lui si avvicina nuovamente, accende una sigaretta e mi butta il fumo in faccia. Si siede nei sedili della fila opposta e mi fissa. Finalmente arriva la mia fermata, aspetto qualche istante in modo da non far capire che scenderò, poi rapidamente corro via e scendo dal treno. Odio prendere il treno d’estate.
– Una sera esco con una cara amica per festeggiare i buoni risultati universitari di entrambe. Siamo in un famoso locale di Torino a sorseggiare una birra e a ridere, come due amiche complici e soddisfatte dei reciproci successi. Due uomini si avvicinano, iniziano a parlare. Presto la conversazione diventa fuori luogo, io vorrei che andassero via. Uno di loro, allunga le mani sul decolleté della mia amica: senza senso, senza motivo, senza permesso. La mia amica si pietrifica, non riesce a reagire. Con forza ed enfasi lo spingo via, gli urlo di andarsene. Nessun’altro dice nulla.
-Ricordo che mia mamma in più di un’occasione mi aveva spiegato come difendermi: di urlare forte se mi fossi sentita in difficoltà, di attirare l’attenzione dicendo che quel dato individuo si era sentito male, in modo tale che l’attenzione ricadesse su di lui e io potessi allontanarmi.
Da ragazzina ero molto più coraggiosa di oggi, spavalda, sicura che in qualche modo mi sarei difesa e che niente e nessuno mi avrebbe fatto del male.
Oggi sono meno sicura ma mi sforzo di non aver paura, uso il buon senso e non mi espongo a rischi eccessivi. Quando torno a casa la sera tardi uso dei piccoli “stratagemmi”.
Prima di scendere dalla macchina prendo le chiavi di casa, tenendo la chiave del portone stretta tra due dita, se parcheggio relativamente lontano cammino sul lato più esterno del marciapiede, cioè vicino alla strada e non al muro. Aguzzo l’udito, bado sempre ad avere una mano libera, non tengo i capelli raccolti in una coda, se aspetto l’ascensore poggio le spalle al muro.
So che è una limitazione, ma sento che ormai è una parte automatica di me: da un lato mi protegge, dall’altro lo combatto perché è ingiusto”. D., 35 anni
“Lavoro in un negozio e mi capita spesso che i clienti si comportino in modo inappropriato. C’è un signore distinto sulla settantina, molto ben visto, che ogni volta che esco dal bancone per prendergli qualcosa mi squadra dalla testa ai piedi indugiando con aria sodisfatta come a dire – Che bella cosa che sto guardando! -. Io alzo gli occhi al cielo, gli faccio delle battute per fargli capire che non è il caso ma serve a poco. Poi purtroppo (e mi rendo conto che non è giusto) io sono anche in una situazione difficile: glielo faccio capire ma devo sempre un po’ tenermi, non rispondo come vorrei…perché comunque sono clienti. Come mi fa sentire? Scocciata, infastidita, disgustata!
Ce n’è un altro che da anni, invece, mi chiede di uscire insieme, anche davanti a mio padre! Io gli rispondo sempre male ma non capisce. Uno, due, tre…poi basta! Non è necessario che ogni volta che mi vedi me la conti che sono bella e mi inviti a uscire. Stop, è arrivato il momento di smetterla! Il fatto è che siccome la mette sul gioco e lo scherzo lui pensa che gli sia consentito, ma in realtà è un consenso che si prende lui e che non gli ho mai dato io. Ti fa sentire stanca, arrabbiata perché il No è un No! Perché non riesci a capire il senso di un no ma ti prendi il diritto di continuare quando te lo dico? È come se il nostro No non avesse valore, non c’è rispetto del mio No”. V., 32 anni
“– Avrò avuto 14 o 15 anni ed ero sul pullman per il mio consueto tragitto casa-scuola. Palpate e strusciamenti indesiderati erano all’ordine del giorno, tanto che viaggiavo coi gomiti in fuori e con le amiche ci guardavamo le spalle. Un giorno mi è capitato davanti un anziano al quale subito non ho prestato attenzione. Nel momento in cui il pullman si è riempito, però, me lo sono trovato appiccicato a un palmo dal naso. Approfittando della confusione e del poco spazio vitale, con la mano ha slacciato la patta dei miei pantaloni (che non avevano la zip ma ben 3 o 4 bottoni!) e ha intrufolato le dita sopra la biancheria afferrandomi per il pube. Ricordo la vampata di calore e il fischio nelle orecchie per l’allarme e la rabbia, ma nonostante aprissi la bocca per protestare non ne è uscito suono. Alla prima fermata è velocemente sceso e io sono rimasta pietrificata ancora per un po’.
– Da più grande, universitaria, una sera stavo rientrando a casa dei miei e non si trovava mai parcheggio vicino. Ho messo l’auto nella via parallela e dovevo fare mezzo isolato a piedi per tornare a casa. Sapevo che sarei dovuta passare di fronte a un pub che raccoglieva sempre gruppi di uomini alticci, ma la strada alternativa era più buia e isolata. Mi son fatta coraggio e gli son passata davanti a passo spedito e con le chiavi pronte in mano impugnate tra le dita. A parte qualche battuta o fischio, nulla di che per fortuna. Svoltato l’angolo, però, mi accorgo che un tizio che stava in auto di fronte al pub, inizia a seguirmi guidando a passo d’uomo, dicendomi schifezze dal finestrino abbassato. Per arrivare al portone mi mancavano ancora almeno 5 minuti a piedi. Ho fatto la strada accelerando e chiamando i miei sperando si svegliassero per venirmi incontro o almeno aprirmi la porta in tempo. Per fortuna hanno aperto il portone perché non so se sarei riuscita ad infilare le chiavi dal panico che avevo. Il tizio mi ha comunque seguita fino al portone di casa continuando a ridere e dire oscenità. Ho fatto fatica ad addormentarmi. Ricordo che i miei mi hanno proposto di tenere una mazza da baseball nel bagagliaio!
– Quando torno a casa la sera tengo le chiavi in mano, a volte chiamo qualcuno o fingo di parlare, appena raggiungo l’auto metto la sicura, non parcheggio mai nei sotterranei e ho attivato il tasto di emergenza sul telefono. Inoltre, nel mio lavoro di psicoterapeuta, quando faccio una prima seduta con un uomo adulto cerco di avere un/a collega nell’altra stanza. Spesso non ci riesco e allora avviso qualcuno a cui confermerò per messaggio se mi sembra tutto ok”. V., 35 anni
Dott.ssa Valeria Lussiana
Psicologa Psicoterapeuta
Fonti:
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/gravita-e-conseguenze
https://www.bbc.com/news/uk-56384600
https://www.valigiablu.it/sarah-everard-violenza-donne-polizia/
https://www.internazionale.it/opinione/arwa-mahdawi/2021/03/15/everard-corpo-donne
https://news.sky.com/story/sarah-everard-six-high-profile-women-on-the-impact-of-33-year-olds-death-and-how-police-handled-vigil-in-her-honour-12245704
https://www.bbc.com/news/world-56337819
https://www.bbc.com/news/newsbeat-56361529
https://www.ilpost.it/2021/03/19/sarah-everard-femminicidio-londra/
https://ihaveavoice.it/sarah-everard-rapita-uccisa/
https://ilbolive.unipd.it/it/news/2020-stato-lanno-peggiore-femminicidi
https://www.stateofmind.it/2020/11/molestie-di-strada-psicologia/
https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a34723281/notallmen-hashtag-significato/
https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2015/05/29/notallmen/
https://time.com/79357/not-all-men-a-brief-history-of-every-dudes-favorite-argument/
https://donna.fanpage.it/le-donne-spiegano-agli-uomini-come-farle-sentire-piu-al-sicuro-5-consigli-da-seguire/
https://www.ilpost.it/2021/03/16/australia-proteste-violenze-genere/
https://freedamedia.it/2020/02/20/le-molestie-da-strada-sono-molestie-non-minimizziamole/?fbclid=IwAR3KLncP1vMEnYu8f_Rxwz4tzlq3qsel7XDv4w7AdZJQSm3NLZkVn4UkXMg
https://www.instagram.com/p/CNHL4NmFHt-/?igshid=4by25h31r4l8
https://www.instagram.com/p/CM6xgGQlZBj/?igshid=1mvveorw09p99
https://www.instagram.com/p/CHsXt3vFkas/?igshid=1ej5dvfqpptar
https://www.instagram.com/p/CMdXePDAtsy/?igshid=10of07ynyxwr7
https://www.youtube.com/watch?v=fMLnCVmZ-_U
https://www.youtube.com/watch?v=bGZbyUGm3vs&t=125s






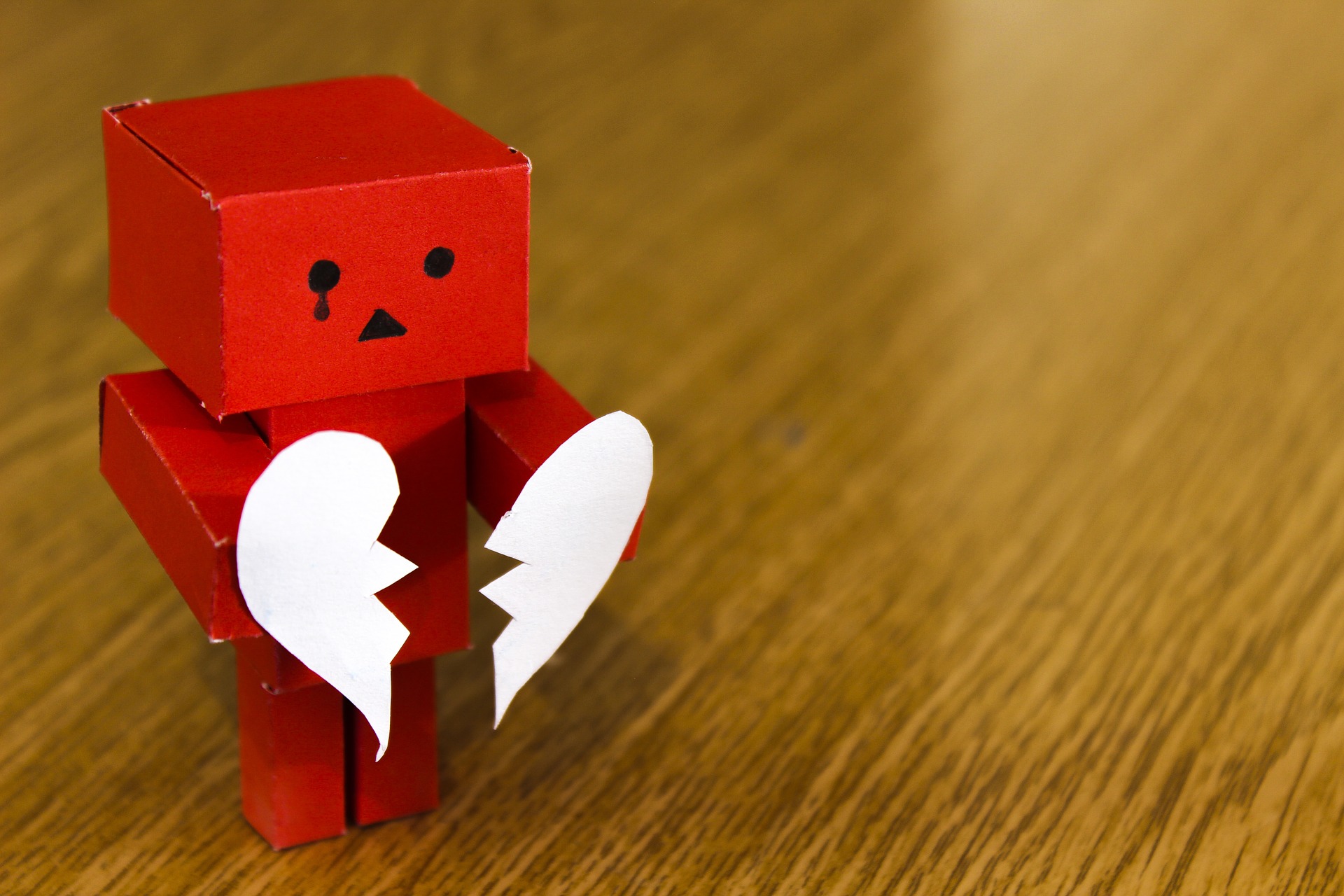










 “La fratria, in effetti, può essere: un mezzo,
“La fratria, in effetti, può essere: un mezzo,