“Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine.
E’ solo che odio le delusioni”
Haruki Murakami
Le ricerche sull’attaccamento e sulla relazione madre-bambino, dimostrano quanto, per ciascuno di noi, sia importante creare relazioni con gli altri. Fondamentalmente è la relazione con l’altro a determinare la nostra identità (Bowlby, 1989; Bartels & Zeki, 2004).
Il processo di individualizzazione si fonda sul bisogno di appartenenza e di differenziazione.
L’appartenenza è il bisogno del bambino di appartenere e riconoscersi nella sua famiglia d’origine. Con la crescita, il ragazzo prima e l’adulto poi, sentirà la necessità di appartenere non solo al suo nucleo d’origine, ma anche di appartenere al contesto sociale in cui vive (Bateson,1977). L’uomo, costruendo la propria rete di relazioni interpersonali, riuscirà a definire così, il proprio sé e l’altro da sé.
Per Hawkly e Cacioppo (2010), il bisogno di appartenenza è coinvolto nello sviluppo dell’intersoggettività: “il senso di connessione sociale funziona come un’impalcatura per il sé; se si danneggia l’impalcatura, il sé inizierà a crollare”.
Il bisogno di differenziazione permette il raggiungimento della propria individualità. La ricerca di relazioni interpersonali appaganti e durature all’interno di un contesto sociale più ampio, porterà ciascuno di noi a sentirci parte integrante di un tutto e contemporaneamente a mantenere la nostra indipendenza e individualità.
Appartenenza e differenziazione pur assolvendo a funzioni differenti sono la spinta motivazionale a creare relazioni, orientando così il nostro comportamento, le nostre emozioni e i nostri pensieri (Liotti & Farina, 2011).
Perché ci sentiamo soli? Innanzitutto, è importante distinguere tra solitudine e isolamento.
La solitudine è infelicità, può rappresentare un tratto distintivo della persona o essere una risposta transitoria a circostanze esterne come lutti, rotture o cambiamenti. Non richiede un necessario isolamento fisico ma piuttosto un’assenza di vicinanza, di contatto, un grado di intimità desiderata che non sempre si è in grado di raggiungere nonostante il contesto sia favorevole. Non tutti sono stati accompagnati in modo stabile dalla solitudine, ma più o meno tutti da posizioni e prospettive diverse hanno dimostrato una particolare sensibilità nel percepire “muri e ostacoli” tra le persone, sensazioni di isolamento e invisibilità. La solitudine è l’esperienza di sentirsi separato dagli altri, di non appartenenza e non condivisione, è sinonimo di insicurezza e auto-svalutazione. Fin da piccoli, quando sperimentiamo un disagio, sia esso emotivo (tristezza, paura, ansia) o fisico (dolore, stanchezza..), sentiamo il bisogno di ricevere affetto dalla nostra figura di accudimento, generalmente la mamma. Il bambino cercherà la vicinanza e protezione dell’altro gridando e piangendo. Quando otterrà una risposta amorevole e accogliente, riuscirà a calmare la sua attivazione fisiologica, disinnescando la risposta alla minaccia.
Cancrini ha evidenziato come questa relazione di tipo filiale/genitoriale vada oltre il legame di sangue diretto, sostituendo il suddetto termine con legame degli affetti. Tutti quei legami che assumono grande importanza per lo sviluppo degli individui, ma che possono non essere naturali: “ figlio o figlia ti è, penso, colui o colei a cui hai dato e da cui hai preso, in una posizione di cura, nello scambio continuo da cui si concreta la vita di relazione, elementi costitutivi della sua identità” (Cancrini, 2020).
I legami, dunque, ci aiutano a sviluppare le nostre capacità di regolazione emotiva. In età adulta, le relazioni, pur orientandosi verso una maggiore reciprocità continueranno ad avere un ruolo fondamentale per il mantenimento del nostro benessere. Anche da grandi avvertiremo il bisogno di sentirci visti, compresi e di poter contare sul supporto di persone per noi importanti. Il bambino che avrà fatto esperienza di un attaccamento sicuro, sarà un adulto capace di tollerare la solitudine e la conseguente sensazione di disorientamento, mantenendo la propria identità integra anche in assenza di una figura di riferimento benevola e protettrice. Seguendo le acquisizioni più recenti della neurobiologia, “la mente si forma nell’ambito delle interazioni fra processi neurofisiologici interni ed esperienze interpersonali e i collegamenti umani plasmano lo sviluppo delle connessioni nervose che sono alla base del nostro cervello” (Mucci, 2014). Se la felicità degli esseri umani è legata al vivere con gli altri, per cui i fattori decisivi del successo riproduttivo dell’uomo si fondano sull’empatia, sulla cooperazione e sui legami sociali (Cacioppo 2009), allora la solitudine è una condizione patologizzante, che trasforma il bisogno insoddisfatto dell’altro in sensazioni, pensieri e comportamenti ostili. Il sentirsi soli non è necessariamente sinonimo di essere soli e isolati. Ciascuno di noi si è sentito solo, per tempi più o meno prolungati, per propria scelta o a causa di condizioni esterne. Il senso di solitudine bussa alla nostra porta quando vorremmo ricevere amore, contenimento, compagnia, ma sembra difficile riuscirci. Si torna così al tempo iniziale della vita e dello sviluppo emotivo, quando il bambino ha fatto esperienza di sentirsi solo in una situazione di bisogno, vivendo una condizione familiare di forte precarietà affettiva ed emotiva. Oppure si torna al tempo adolescenziale o adulto, quando un evento o un problema, porteranno la persona a confrontarsi con le proprie fragilità, per cui il sentirsi soli si trasformerà nel sentimento della solitudine. L’impatto emotivo che le interazioni dell’infanzia hanno sullo sviluppo della personalità di ciascuno di noi, evidenzia il complesso rapporto tra essere soli, sentirsi soli, e la solitudine nel processo del divenire se stessi (Benjamin). In questi casi, l’altro diventa per noi imprevedibile, la paura di essere ignorati e abbandonati in qualsiasi momento pietrifica anche la nascita dell’amore, in alcuni casi la sensazione di disconnessione-vuoto dagli altri è così forte che qualsiasi azione dell’altro non riesce a colmare il nostro bisogno di attenzione e amore. Boon, Steel e Van der Hart (2013) parlano di fobia della perdita dell’attaccamento.
In questi casi si instaurano relazioni complesse caratterizzate da:
• comportamenti altamente richiestivi verso l’altro, si pretende sempre maggiore vicinanza, attenzioni e risposte sempre più rapide (“perché non mi hai risposto subito?..mi vuoi lasciare?…). Diventa difficile tollerare la frustrazione dell’assenza dell’altro perché magari impegnato nel suo quotidiano. Tutto diventa una misura di quanto l’altro tiene a noi, sembra quasi impossibile regolare le emozioni senza l’aiuto degli altri e, per di più, questo aiuto non sembra mai sufficiente.
• oppure al contrario, mostrare comportamenti passivi, anticipando sempre i bisogni dell’altro e mettendo in secondo piano i propri (“Vengo subito da te anche se avrei dovuto finire delle cose di lavoro”..). Queste modalità finiscono per esaurire le energie mentali e fisiche, accumulando rabbia e risentimento.
Qualsiasi sia la strategia, quello che si avverte è un profondo bisogno di contatto e protezione che fatica ad essere colmato. Nascono relazioni non equilibrate che inevitabilmente andranno a confermare l’idea che gli altri siano portati prima o poi a deluderci. A valle della solitudine ci sono molti schemi comportamentali disfunzionali che si ripetono, senza neanche esserne consapevoli. L’agire per ripetizioni spesso ha a che fare con la trasmissione intergenerazionale, viene passata da una generazione all’altra, da padre a figlio, da madre a figlia, e la relazione con l’altro riattiva vecchie ferite dell’infanzia (Benjamin 2004).
Spesso accade che le persone desiderano una relazione, ma contemporaneamente la temono; questo comporta un’ ipervigilanza rispetto alle minacce sociali, l’individuo tende a percepire il mondo in termini sempre più negativi isolandosi sempre di più. Chi si sente isolato e fuori dal giro delle relazioni sociali, inizia a sviluppare una serie di comportamenti negativi che hanno lo scopo di non incontrare gli altri, per evitare di essere rifiutati. Una sorta di atto di difesa che non fa altro che aggravare il malessere di partenza.
Ecco alcune credenze in grado di perpetuare l’isolamento sociale:
• nel corso della propria esistenza, alcune persone a seguito di ripetute critiche e svalutazioni potrebbero faticare a fidarsi degli altri, attribuendo a quest’ultimi intenzioni malevole. L’isolamento diventa così una strategia per prevenire ulteriori sofferenze o delusioni.
• le relazioni sono pericolose. E’ meglio essere totalmente autosufficienti. In questi casi è possibile sperimentare un senso di minaccia, paura o pericolo all’interno delle relazioni. Sulla base di ciò ritirarsi dalle relazioni è una risposta comprensibile.
• “se vedessero i miei difetti, non potrebbero amarmi”. Quando ci si sente così, profondamente sbagliati, l’isolamento è quindi un modo per non incorrere nel rischio che gli altri scoprano chi si è realmente.
Queste sono alcune delle credenze che rinforzano la sensazione di non poter essere in sintonia con gli altri, di poter creare legami interpersonali basati sulla vicinanza empatica e sull’ascolto. In questo modo diventa difficoltoso accedere ad esperienze relazionali positive, fondamentali per modificare le credenze rigide e inflessibili che condizionano i nostri rapporti presenti. In questo modo il passato ritorna prepotente nel nostro presente, per sentirci al sicuro facciamo e ripetiamo quello che abbiamo visto fare dalle nostre figure di riferimento. Come dice la Benjamin il patto di lealtà con le figure di riferimento è un “dono d’amore”, è la ricerca di un’intimità tanto desiderata e sognata e contemporaneamente è la perdita della propria differenziazione, del riconoscimento delle proprie idee, pensieri e atteggiamenti.
Alla luce delle considerazioni fatte, la solitudine ha origini lontane ed è espressione di un problema di differenziazione, di individuazione e d’amore: la sofferenza che genera il sentirsi soli, racconta sempre di un percorso di individuazione che è stato messo a repentaglio dal senso di mancanza, di assenza, di vuoto, che la distanza dall’altro suscita. L’atto di rinuncia alla propria identità si manifesta nelle diverse relazioni di dipendenza, sconfinando in un isolamento/solitudine che, seppur con differenti posizioni, asseconda il bisogno di protezione di non esposizione, accrescendo il proprio sentirsi insicuri ed inadeguati , incapaci per sé e per gli altri.
Dott.ssa Angela Pia Gianpalmo
Psicologa – Psicoterapeuta
Bibliografia
1. Barles, A.; Zeki, S.(2004). The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage, 21, 1155-1166.
2. Bateson, G. (1977). Verso un’ecologia della mente. Adelphi, Milano.
3. Benjamin, L.S.(2004). Terapia ricostruttiva interpersonale. Promuovere il cambiamento in coloro che non reagiscono.LAS, Roma.
4. Boon, S.; Steele, K.; Van Der Hart, O. (2013). La dissociazione traumatica comprenderla e affrontarla. Mimesis Edizioni, Milano
5. Bowlby, J. (1989). Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento. Milano: Raffaello Cortina Editore.
6. Cacioppo, J. T.; William, P. (2009). Solitudine: l’essere umano e il bisogno dell’altro. Il Saggiatore, Milano.
7. Cancrini, L., (2020). La sfida all’adozione. Cronaca di una terapia riuscita. Raffaello Cortina Editore Milano.
8. Liotti G., (2010) Lo studio della motivazione in una prospettiva evoluzionistica: cenni storici e concetti di base. Raffaello Cortina Milano
9. Liotti, G., Farina, B. (2011). Sviluppi Traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Milano: Raffaello Cortina Editore.
10. Mucci, C., (2014). Trauma e perdono. Una prospettiva psicoanalitica intergenerazionale. Raffaello Cortina Editore, Milano.



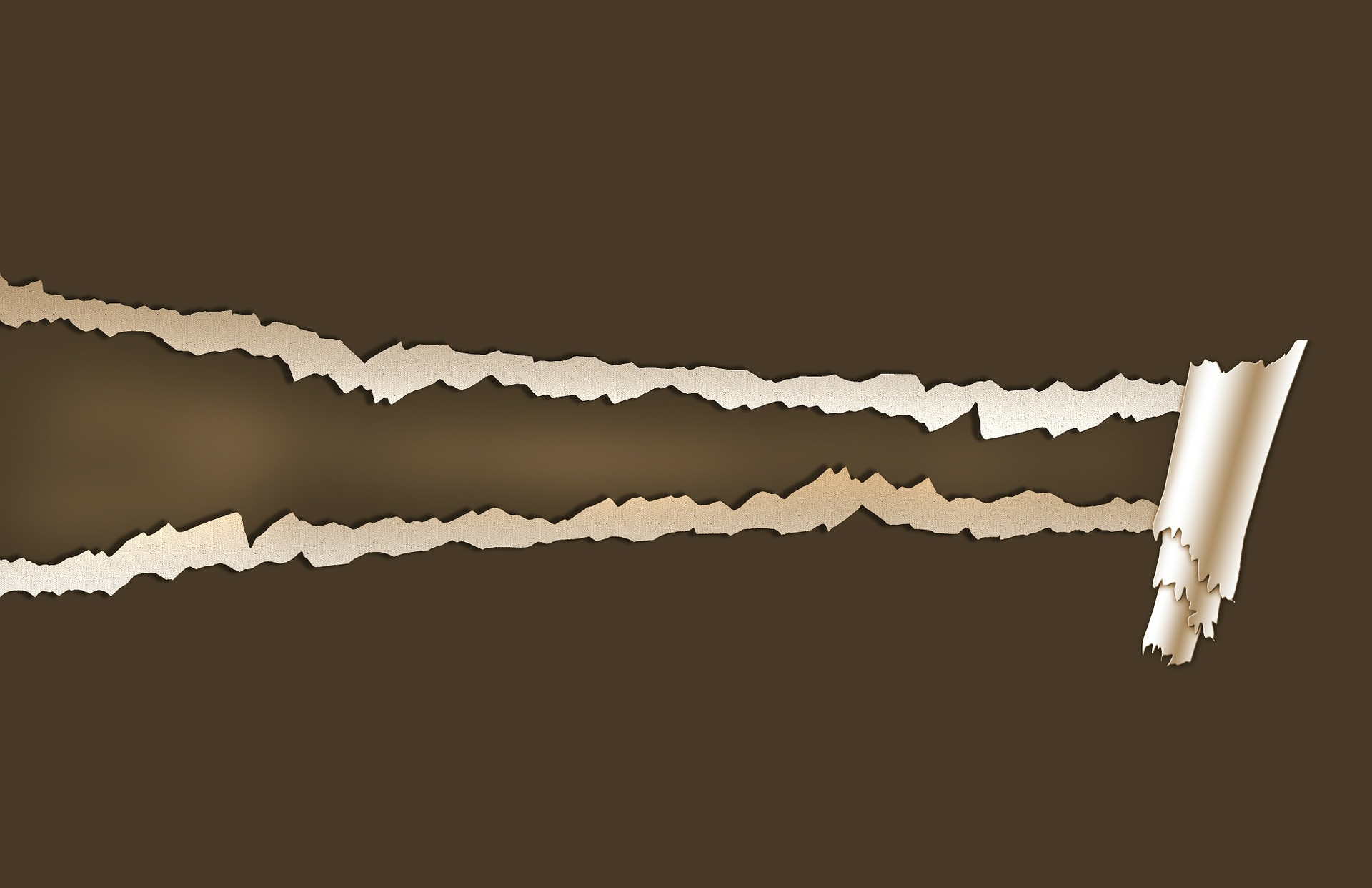








 Ciao io sono la giraffa e sono il simbolo della comunicazione non violenta, perché sono Il mammifero terrestre con il cuore più grande e con il mio lungo collo posso avere una visuale più ampia. Con la comunicazione non violenta si è più capaci di comunicare, di gestire i conflitti e di empatizzare con sé e gli altri. L’empatia è la base della comunicazione non violenta. Quando ho le orecchie rivolte verso l’altro sto cercando di capire i suoi bisogni e motivazioni ecc. Quando ho le orecchie rivolte indietro lo sto facendo con me stessa.
Ciao io sono la giraffa e sono il simbolo della comunicazione non violenta, perché sono Il mammifero terrestre con il cuore più grande e con il mio lungo collo posso avere una visuale più ampia. Con la comunicazione non violenta si è più capaci di comunicare, di gestire i conflitti e di empatizzare con sé e gli altri. L’empatia è la base della comunicazione non violenta. Quando ho le orecchie rivolte verso l’altro sto cercando di capire i suoi bisogni e motivazioni ecc. Quando ho le orecchie rivolte indietro lo sto facendo con me stessa. sia la tua età: bambino o adulto, qualunque sia il tuo ruolo: genitore, educatore, insegnante, o lettore, questo libro ti prenderà per mano per aiutarti, divertendoti, ad acquisire gli strumenti necessari a comunicare in modo efficace e a perdonare.
sia la tua età: bambino o adulto, qualunque sia il tuo ruolo: genitore, educatore, insegnante, o lettore, questo libro ti prenderà per mano per aiutarti, divertendoti, ad acquisire gli strumenti necessari a comunicare in modo efficace e a perdonare.