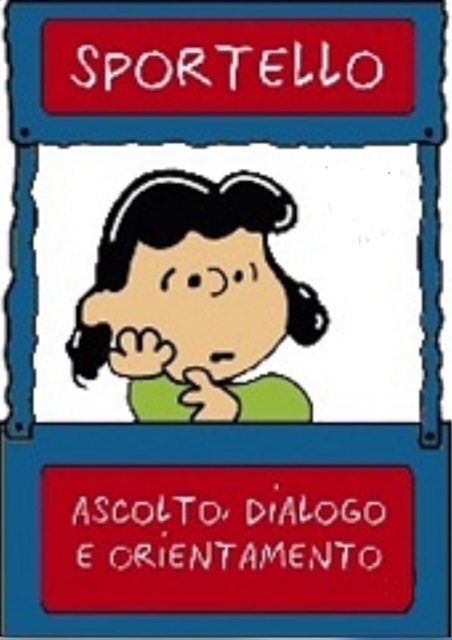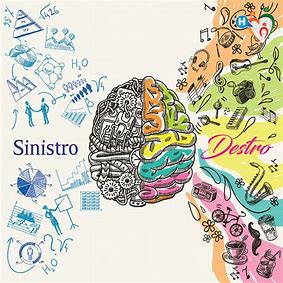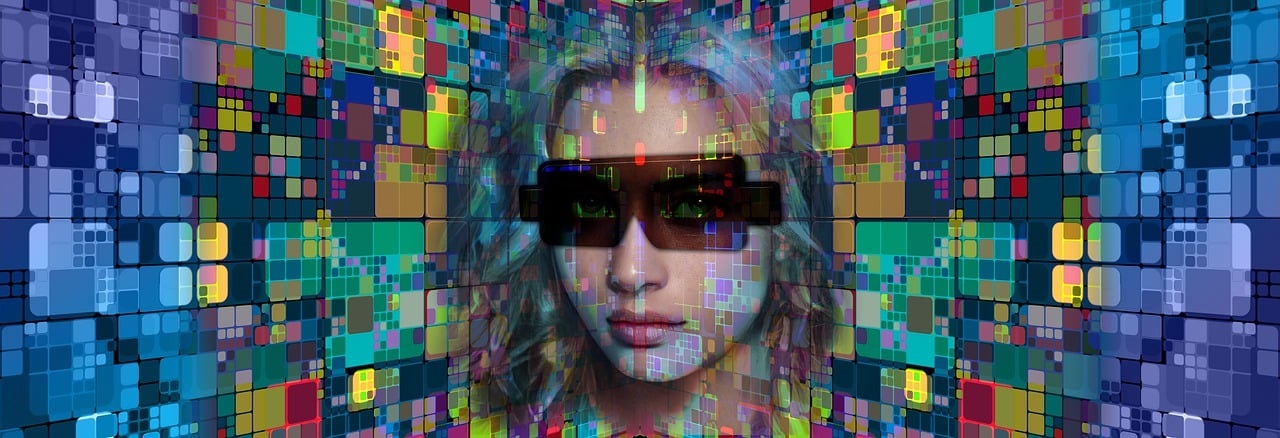NARRAZIONE DEL DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITA’: recensione di “UNA MENTE IN FRAMMENTI – Origini e cura del disturbo da deficit di attenzione” di Gabon Matè – Casa Editrice Astrolabio
Come pensa, sente, agisce una persona con disturbo da Deficit di attenzione e iperattività (ADHD)?
Gabol Maté delinea in “Una mente in frammenti” cosa accade nella mente di un ADHD prendendo a modello la sua esperienza e le citazioni dei suoi pazienti. L’autore offre al lettore una riflessione profonda su come si muove nel mondo e quali sono i vissuti di chi affronta questa diagnosi, quali i
correlati genetici e ambientali che portano all’esordio e sviluppo di questa neurodivergenza e infine come è essere uomini, donne, genitori, partner, amici, bambini o professionisti con ADHD.
Lo fa attraverso la voce di psichiatra ma anche di padre e di uomo con questa diagnosi mettendo in luce il substrato sociale che origina, sostiene e cronicizza il disturbo: come è soffrire di ADHD nella nostra società e in questo mondo accelerato e orientato alla performance?
Gabor Maté in “Una mente a frammenti” ci offre una visione chiara dei limiti e delle risorse di piccoli e adulti con ADHD oltre che proporre strategie di sostegno a genitori con figli ADHD coniugando la sua storia personale ad informazioni di carattere scientifico in un linguaggio semplice
e a tratti commovente.
Cos’è l’ADHD?
L’ADHD o Disturbo da Deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è classificabile come un disturbo del neurosviluppo ed è generalmente diagnosticata durante l’infanzia. Ad oggi però, con la
maggiore diffusione di ricerche e informazioni sul tema emerge sempre più spesso nella popolazione adulta il bisogno di trovare uno sfondo a sintomi e ad una sofferenza spiegabile e comprensibile sotto il cappello di questa diagnosi.
L’ADHD è caratterizzata da una fatica in queste specifiche aree: attenzione, iperattività e impulsività.
– Attenzione: la mente di un ADHD saltella e svolazza come un uccello impazzito. Spesso la sensazione è quella di uno scollamento tra mente e corpo dove la mente è immersa in un mondo diverso, di fantasie e pensieri. Matè riporta la descrizione di un suo paziente che si identifica in una giraffa con la testa che si affaccia su un altro paesaggio, molto più alto e ricco di sfumature rispetto a quello vissuto dal corpo nel momento presente: questa metafora ben dettaglia la sua fatica nello stare nel mondo. La distraibilità e la mancanza di concentrazione si rivela in modo discontinuo. Non è raro osservare infatti nelle persone con ADHD un movimento di massima concentrazione connesso ad un alta motivazione o interesse tanto da escludere tutti gli stimoli circostanti e da
immergersi completamente nel compito (es. svolgere un attività con la tv accesa) e viceversa quando il compito non è attraente l’esperienza di un ADHD è quella di vagare e perdersi tra tutti gli stimoli interni ed esterni presenti. Ecco che questo spiega un rendimento discontinuo nei bambini ADHD e la difficoltà degli stessi ad essere compresi e accettati nella loro mancanza di
concentrazione come se fosse riferibile solo alla scarsa volontà e intenzionalità. Più che di distrazione nelle persone ADHD potremmo allora parlare di in-attenzione ovvero la difficoltà a concentrarsi su stimoli non ritenuti interessanti. Nella mente di un ADHD domina il caos, la distraibilità porta infatti a essere facilmente agganciati ad uno stimolo che a sua volta si affianca ad un altro e ad un altro ancora, rischiando di far perdere il focus iniziale. Quasi ogni ADHD racconta di entrare spesso nella stanza per prendere una cosa e una volta lì non sapere cosa lo ha spinto ad arrivarci, dimenticandosi quindi il motivo per cui era entrato. Le persone ADHD si propongono dei
piani o delle attività anche quotidiane e semplici (es. riordinare una camera) che in breve tempo sembrano fallire poiché si viene catturati continuamente da diversi riferimenti lasciando tutto incompiuto e perdendo l’imput iniziale. Un esempio potrebbe configurarsi così: mentre riordino la stanza, mi ricordo di fare la lavatrice e mi muovo in quella direzione, arrivo davanti alla lavatrice
scordandomi ciò che dovevo fare, vengo attratto da un’altra attività e così via con l’esito di non aver assolto al compito originario.
La confusione interna riflette quella esterna: sembra infatti mancare il “chip dell’ordine” scrive Maté, poiché l’individuo sembra sprovvisto di uno schema mentale necessario a comprendere il processo attraverso il quale si riordina. É come se fosse chiara la meta ma mancasse la mappa. Il soggetto ADHD riesce quindi ad immaginare l’obbiettivo ma non sa come arrivarci. Inoltre alla
distraibilità si coniuga, generando maggiore sofferenza, il bisogno delle persone ADHD di ricercare sempre esperienze di novità e stimolazione sensoriale nel tentativo di scappare dalla dolorosa sensazione di noia ricorrente. Questa caratteristica è accentuata da un ruolo importante giocato dalla dopamina, un neurotrasmettitore utile anche nella regolazione dell’umore, nella memoria e nella
gratificazione. Nei soggetti ADHD le ricerche scientifiche si muovono proprio nella direzione di esplorare carenti livelli di dopamina o difficoltà nella sua ricaptazione. Il meccanismo della disattenzione e dell’essere attratti da numerosi stimoli non si manifesta solo in attività pratiche ma
anche nella comunicazione. Il pensiero sembra andare sempre un po’ più in là rispetto al linguaggio con il rischio di saltare delle parole e rendere l’eloquio sconclusionato e illogico.
– Iperattività: può mostrarsi in un irrequietezza del corpo (es. alzarsi spesso), del linguaggio (es. incontinenza verbale ed eccessiva loquacità) o dei pensieri. Una persona con ADHD vive un disagio nel restare ferma fisicamente con il bisogno continuo di muoversi e giocherellare con oggetti. Nelle
conversazioni sono frequenti movimenti oculari di esplorazione dell’ambiente che possono essere percepiti dall’interlocutore come mancanza di interesse o infastidire nell’interazione. Mentre nei bambini è più facile notare iperattività corporea, negli adulti sono comuni sintomi di overthinking.
Questa sensazione è descritta come un rumore bianco o un brusio persistente dei pensieri che faticano ad essere colti o intercettati dalla persona stessa. La costante vivacità unita alla fatica a concentrarsi porta le persone con ADHD a non godere appieno del presente o avvertire la spiacevole impressione di non avere attimi di riposo e rilassatezza. C’è sempre qualcosa di importante che sembra sfuggire alla mente, la perpetua preoccupazione di star perdendo qualcosa che sembra inafferrabile a livello cognitivo. I pazienti con ADHD riferiscono di non riuscire a “prendersi neanche una pausa da se stessi”, di “essere stanchi”. Gabor Matè si descrive come un giocoliere in equilibrio precario impossibilitato ad interrompere la propria esibizione. L’agitazione perenne porta a conseguenti sensazioni di letargia, sconforto e sintomi
depressivi in risposta alla fatica data da un iperattività cognitiva o fisica e dal mettere continuamente in atto strategie compensative.
– Impulsività: può rivelarsi non solo nell’agire (es. acquisti impulsivi, alimentazione) ma anche nelle situazioni sociali (es. fatica a rispettare il proprio turno di parola, sovrapporsi della voce dell’altro). Le persone con ADHD il più delle volte agiscono mossi da una sensazione di urgenza con il bisogno di immediata soddisfazione dei propri desideri. Senza questa lotta contro il tempo o l’ottenimento di una ricompensa veloce è facile scivolare per una persona ADHD nell’inerzia e nella procrastinazione. Non è raro che questi pazienti si riducano all’ultimo momento nella consegna di un compito o di un attività programmata. A tal proposito le persone con ADHD sentono di avere moltissimi potenziali inespressi o competenze e qualità che faticano a valorizzare e a sviluppare nel tempo; questo si traduce in numerosi progetti mai realizzati o abbandonanti dopo un primo intenso entusiasmo per la novità che sottrae alla noia, la quale si configura come un’esperienza estremamente spiacevole e spaventosa per una persona con questa diagnosi. Nei bambini o adulti con ADHD è facile quindi notare una dispercezione dello scorrere del tempo. Il senso del tempo sembra essere quello di un infante: o è qualcosa che si riferisce all’istante e al momento immediatamente presente, o al contrario sembra infinito. Il futuro nella mente di un ADHD è come se non riuscisse ad essere tenuto in considerazione e ricordato. Le implicazioni e le conseguenze sembrano infatti non essere visibili e tutto è agito sull’impulso del momento presente.
I progetti a lungo termine vengono procrastinati fino a che non diventano a breve termine e quindi portati a compiutezza nell’affanno e nell’urgenza. Questo si correla emotivamente a sensazioni di ansia, sentirsi sopraffatti, ritardo cronico e sofferenza. Da una parte allora la persona ADHD non
riesce a vivere nel presente e a godersi il qui e ora, dall’altra tutto sembra sopraggiungere nell’immediatezza e anche se può sembrare paradossale è molto coerente con l’inafferrabilità del concetto di tempo, temporalità e di spazio che caratterizzano le persone con questa diagnosi.
Un esempio personale che riporta l’autore è proprio quello di ridursi all’ultimo nell’uscire di casa ogni mattina non prendendo in considerazione l’ipotesi che possano sopraggiungere imprevisti (es. sbrinare il vetro della macchina dal ghiaccio, che vi sia traffico lungo il tragitto, dimenticanza di
alcuni oggetti in casa) con la conseguenza di essere puntualmente in ritardo.
Come si sviluppa l’ADHD?
L’ADHD ha un eziopatogenesi multifattoriale: esiste una predisposizione genetica ed ereditaria ma è essenziale considerare anche il valore dell’ambiente e delle relazioni di attaccamento. In accordo con l’autore è bene tenere presente la vicendevole influenza di geni e ambiente escludendo così un
approccio riduzionistico allo sviluppo della patologia.
Per ciò che concerne basi biologiche ed ereditarie, si evidenzia un deficit della corteccia prefrontale destra che nell’organismo funziona da vigile per dirigere il traffico di pensieri, azioni e impulsi. Nel caso nelle persone con ADHD quest’ultima lavora in modo semi-dormiente causando soprattutto difficoltà nell’inibizione degli impulsi. Anche un incompleto sviluppo della corteccia orbitofrontale (OFC) sembra giocare un ruolo decisivo per alcune importanti funzioni che risultano deficitarie nelle persone con ADHD. Alterazioni dell’OFC possono avere effetti sulla regolazione degli stimoli interni ed esterni, sull’inibizione degli impulsi fisici ed emotivi, con conseguente difficoltà a
differenziarsi nel processo di indipendenza e maturità. Nello specifico, i centri inferiori del cervello sembrano essere implicati nel controllo degli impulsi e nel generare senso di urgenza tipico degli ADHD. L’OFC ha connessioni anche con il controllo dell’attenzione e con la capacità di localizzazione nello spazio o con regioni deposte all’orientamento e all’acquisizione di competenze
-spaziali. Nelle persone con ADHD non è raro notare una difficoltà in tali abilità: sono spesso disorientati e non riescono a riconoscere o seguire le indicazioni stradali. Le ricerche mostrano inoltre che l’ADHD si correla positivamente ad alcuni squilibri ormonali, rilascio di sostante chimiche o deficit nella crescita di circuiti neuronali che giocano un ruolo importante e possono influire ed essere influenzati da esperienze emotive. Tra le interazioni emotive che maggiormente hanno impatto sull’emergere della patologia è possibile riferirsi ai legami di attaccamento. A tal proposito la competenza di sintonizzazione della figura di attaccamento, il soddisfacimento per il
bambino rispetto ad un buon contatto emotivo genitoriale, il movimento materno ad offrirsi come base sicura al piccolo e la competenza a saper cogliere i suoi segnali e condividere l’esperienza emotiva si configura come un fattore protettivo anche rispetto all’insorgere del disturbo ADHD. Dal
punto di vista ambientale stress ed eventi familiari conflittuali o traumatici possono rivelarsi fattori di rischio per lo sviluppo di questo disturbo. Maté citando i suoi pazienti racconta storie di divorzio, abuso, depressione delle figure significative, violenza o alcolismo. Alle volte questi vissuti sono
rimossi proprio perché fonte di troppa sofferenza e rimangono inconsapevoli ai pazienti che arrivano per una diagnosi. Altre volte vengono minimizzati, ridimensionati e sdrammatizzati e anzi si nota nei pazienti il movimento opposto: quello di prendersi la colpa per i castighi e le punizioni ricevute o per le scelte di altri significativi.
ADHD, vissuti ed esperienze relazionali
La fragilità nelle tre aree (attenzione, iperattività e impulsività) porta con se difficoltà su un piano individuale ma soprattutto interpersonale. A livello sociale le persone con ADHD spesso si sentono aliene rispetto ai pari: le interazioni possono essere esperienze sgradevoli quando si avverte la
sensazione di essere annoiati quando non si è centrali nella conversazione e/o disinteressati al racconto dell’altro. È arduo per le persone con ADHD riuscire a tenere il filo della conversazione, saltellano da un argomento all’altro e spesso vengono etichettati come maleducati, arroganti e distanti proprio per aspetti logorroici e di esuberanza verbale o per il ritiro dalla conversazione al
fine di controllarsi e adeguarsi. Non è raro subire fin dalla prima infanzia esperienze di umiliazione o di rimprovero proprio per la fatica a contenersi e a regolare le proprie emozioni.
Bassa autostima e falso se sono rinforzati fin dall’infanzia: persone con ADHD assumono atteggiamenti autodenigratori e sperimentano sensi di colpa, vergogna e autocritica. Molti ADHD riferiscono che nessuno potrebbe essere più feroce e severo di se stesso con se stesso.
Comunemente c’è una tendenza al perfezionismo e reticenza a sperimentare impotenza e a mostrare fragilità. Per difesa viene ostentata un’immagine grandiosa di sé che stona da quella realmente percepita internamente o al contrario ci si presenta continuamente come mediocri, inetti e dipendenti. Pazienti con ADHD hanno bisogno di essere apprezzati e validati e basano la stima sul fare più che sull’essere, traendo soddisfazione solo da successi esterni e dal giudizio altrui. I bambini con ADHD spesso fanno i “pagliacci della classe” o sono considerati come inautentici ed eccessivi nelle loro manifestazioni sociali ed emotive e talvolta imprevedibili e altalenanti
nell’umore. Adulti e bambini con ADHD sperimentano spesso disregolazione emotiva e anche le reazioni possono apparire fuori controllo con conseguente rifiuto nelle esperienze relazionali e gruppali. I soggetti con ADHD sono inoltre percepiti come più immaturi rispetto ai coetanei per atteggiamenti e manifestazioni emozionali infantili (es. adulti con crisi di rabbia come fossero
bambini). Le crisi emotive e le modalità infantili sono definite da un fallimento dell’autoregolazione e dell’inibizione degli impulsi e si correlano comunque ad sviluppo incompleto di alcune vie neuronali che collegano le regioni della corteccia celebrale ad aree inferiori del cervello e ad un aspetto deficitario della corteccia prefrontale destra. Pensiamo alla competenza di
come un termostato che mantiene la temperatura interna costante a prescindere dalle variazioni esterne. Nelle persone ADHD deficit in quest’area determina una facile suscettibilità alle variazioni esterne anche minime che conducono a reagire in maniera automatica seppur senza intenzionalità.
Proprio per lo scarso controllo degli impulsi pazienti con ADHD risultano allo sguardo altrui puerili, incapaci di differenziarsi e di rendersi autonomi. Questo elemento diventa fonte di stress e di angosce profonde sperimentate dalle persone con ADHD e agisce sul senso di autostima e autoefficacia. A tal proposito le persone ADHD patiscono il timore dell’intimità: emerge un bisogno di vicinanza e al tempo stesso il terrore di essere allontanati. Da una parte c’è un disperato bisogno di accudimento e di legame, dall’altra si vive la paura di perdere se stessi nella relazione e il rischio di esserne fagocitati e sopraffatti o abbandonati. I “no” diventano nella mente ADHD un rigetto alla
propria persona più che a quella specifica richiesta o comportamento. Un ADHD fatica a cogliere la differenza tra un normale diniego e un atteggiamento repulsivo, proprio per la tendenza ad esagerare gli stimoli e di conseguenza anche le reazioni agli stessi. Nel processo di cura diventa
fondamentale ricercare, sotto gli impulsi superficiali e le scenate infantili, i bisogni autentici connessi all’autodeterminazione. L’accettazione di sé stessi è un passo determinante: diventa essenziale poter sperimentare di valere non per ciò che si fa, ma di valere a prescindere da quello che si sa fare. Sentire di essere amabili al di là delle aspettative e dell’assoluta disponibilità ad esaudire i bisogni altrui tanto da sopprimere i propri sentimenti. Infatti un ulteriore elemento di fatica relazionale si rivela nella difficoltà a percepire i confini interpersonali: i bambini con ADHD assumono spesso un atteggiamento di benevolenza e apertura eccessivi senza però l’abilità ad interpretare correttamente i segnali sociali e tendono a considerare le relazioni più intime di quello che sono. Le persone con ADHD proprio per una difficoltà a tenere il confine sono incapaci di dire no, rendendosi disponibili e servizievoli a discapito dei propri bisogni. L’individuo con ADHD è guidato da un fortissimo senso del dovere e da responsabilità auto-imposte, che fatica però a
sostenere e portare avanti, con conseguente sovraccarico emotivo. Questo continuo dire di sì a tutto emerge dal bisogno di sentirsi potenti e indispensabili e dalla richiesta inconscia di guadagnarsi merito, accettazione e riconoscimento. Il costo è una profonda sofferenza emotiva che viene
anestetizzata pur di fronteggiare lo stress ambientale. Inoltre così come per la distraibilità anche il senso di responsabilità e disponibilità è molto situazionale: l’autore si descrive come un professionista estremamente dedito al suo lavoro ma come un marito talvolta poco presente che non assolve con così tanto impegno a tutti i suoi doveri interni alle mura domestiche, lì dove si sente più al sicuro e non è mosso dall’urgenza di piacere o dalla paura del giudizio.
Bambini ADHD possono mostrarsi al mondo esterno come profondamente assennati con uno sforzo cognitivo enorme e a casa rivelarsi completamente diversi. Questa fatica a tenere il confine con l’altro emerge anche dal
punto di vista emotivo: lo psichiatra distingue la competenza empatica dall’immedesimazione emotiva propria dei soggetti con ADHD. Essere empatici infatti significa sentire ciò che accade all’altro emotivamente riuscendo a prenderne le distante e a mantenere il confine tra sé e la persona
che sta manifestando la propria emozione. Nel caso dei soggetti ADHD quello che accade è proprio un contagio emotivo e un’appropriazione dell’emozione annullando i confini interpersonali.
Così come per altre neurodivergenze anche nell’ADHD il fenomeno del masking ovvero mascheramento dei sintomi con l’obbiettivo di conformarsi è ricorrente e richiede un grande sforzo cognitivo ed emotivo “Ho trascorso tutta la mia vita facendo finta di essere normale” scrive Matè, citando un paziente. Vengono messe in atto massicce strategie di compensazione, nel tentativo di
assottigliare le differenze con i pari e di mostrarsi meno irrequieti e caotici. Persone con ADHD si uniformano ai bisogni e i desideri degli altri significativi, forzandosi anche a sperimentare emozioni che idealmente “dovrebbe essere sentite” e impegnandosi anche per anni in attività contrarie alla loro natura che rinforzano l’immagine interna fallimentare, di insuccesso e la bassa stima di sé (es. svolgere il lavoro di commercialista nonostante la fatica nei processi logici-matematici). Ecco che questo si associa a vuoto interiore e angosciante quando ci si approccia alla scoperta di se’.
Un altro importante elemento che caratterizza questa neurodivergenza è l’ipersensibilità emotiva e sensoriale. L’autore porta come esempio sua figlia con ADHD al leggero aumentare della voce lamentava al padre di star gridando o al suo leggero variare di tono si sentiva subito rimproverata.
Le persone con ADHD sembrano infatti essere molto ricettive agli stimoli sensoriali esterni (es. uditivi, visivi, tattili, olfattivi) e alle impressioni mentali, e possono reagire a stimoli ed emozioni stressanti ipo o iper attivandosi. Nel primo caso si nota sonnolenza o spegnimento delle energie, che
possono modificarsi repentinamente appena la fonte di stress viene a mancare. Sentirsi sottoposti a bombardamenti di stimoli sensoriali esterni in aggiunta ad un deficit nell’attenzione selettiva,comporta per le persone con ADHD un enorme fatica a vivere il momento presente tanto che la
“dissociazione” può subentrare come uno dei meccanismi di difesa più comuni. La dissociazione, ovvero la tendenza ad assentarsi mentalmente, non va qui intensa in termini di disturbo, ma come autoprotezione. In quest’ottica la dissociazione diventa un anestetico emotivo e si esprime in modo
sempre più massiccio quando si affrontano situazioni intense connesse ad impotenza e/o a sovraccarico, dalle quali persone con ADHD sembrano scollegarsi automaticamente.
Nel secondo caso lo stimolo esterno viene processato attraverso la via breve, ovvero tramite l’amigdala e il sistema limbico senza passare dalla corteccia prefrontale attivando reazioni di ansia e paura immediate ed impedendo la mentalizzazione dello stesso. In questo caso il soggetto sente di essere sotto sequestro emotivo ovvero la sensazione di essere catturati dall’emozione spiacevole immediata e sproporzionata con conseguente disregolazione. Le persone ADHD possono subire degli scompensi sensoriali in situazioni con stimoli eccessivi (es. folla o feste) o sono ipervigili rispetto ai cambiamenti emotivi dell’ambiente che registrano in modo molto raffinato. É come se
avessero della antenne recettive potenti rispetto al minimo variare dell’atmosfera emotiva ed è per questo che spesso vengono classificati come bambini dal temperamento difficile. Uno stimolo ritenuto insignificante per altri può dare origine ad una intensa reazione. Per i genitori comprendere
la loro ipersensibilità non è sempre facile e spesso viene associata ad atteggiamenti oppositivi nei loro confronti con la conseguenza che il figlio venga spesso descritto come irascibile e scontroso.
Matè parla allora di allergie emotive spiegando come la volontà non c’entri. È impossibile infatti chiedere ad una persona che soffre di un allergia di “smetterla di essere così allergico!” o “di limitare la propria reazione”. In accordo con l’autore possiamo perciò pensare alle persone con ADHD come persone dalla “pelle sottile”. Ecco che nel processo di cura diventa indispensabile porsi in ascolto in modo curioso e aperto a ciò che emerge, rinunciando a pretendere di sapere ciò che il bambino pensa o agisce. Non attribuire quindi un significato all’atteggiamento dell’altro (es. mio figlio mi sfida) ma chiedere e orientarsi con fiducia a partire dal dialogo. Elemento
fondamentale per il processo di cura è la presenza, la comprensione e l’accettazione autentica delle caratteristiche e la coltivazione di uno spazio sicuro. Spesso i genitori chiedono come aiutare i propri figli con diagnosi di ADHD.
Le strategie più efficaci sono quelle di vicinanza e sostegno: i genitori dovrebbero dimostrare di desiderare la compagnia del figlio autenticamente e non come senso del dovere, scegliere di coinvolgere il bambino e ricercare il contatto prima di un’esplicita richiesta o invito. E’ fondamentale per un genitore esplorare cosa c’è dietro ai comportamenti disfunzionali del figlio provando a non leggerli come atteggiamenti oppositivi ma alla luce di ansia,
vergogna o rabbia. Questo vale anche per l’adulto che può guardare a se stesso ponendosi degli interrogativi compassionevoli su ciò che gli accade e sul perché dei propri atteggiamenti, trasformando le feroci critiche in domande sul senso di sé. Non è da sottovalutare in questo processo l’importanza del dare e darsi tempo in quanto lavorare sull’urgenza per un ADHD andrebbe a colludere con il proprio funzionamento.
Il bambino con ADHD può vivere costantemente la sensazione di colpa e vergogna con il timore di essere isolato e umiliato. Ecco che il genitore più che contrastare l’atteggiamento auto-denigratorio, con il rischio di rafforzare il senso di inadeguatezza, può prestare attenzione a non alimentarlo e a
sospendere il giudizio. Sia in manifestazioni di critica che di lode il genitore dovrebbe limitarsi a considerare il comportamento piuttosto che complimentarsi o rimproverare la persona. Questo si traduce in un incremento autentico dell’ autostima reale diversa da quella acquisita, ovvero determinata dall’ esterno, che non concede la possibilità di interiorizzazione e accettazione. Il bambino ha bisogno di sentire che sarà accettato e amato per ciò che è, non per ciò che fa bene o male che sia. L’adulto ADHD invece, a tal proposito, può osservare il senso di colpa nelle vesti di guardiano riconoscendo e valorizzando i messaggi che offre e imparando a discriminarne e valutarne il senso, senza obbedirvi in modo cieco.
Obbiettivo finale può diventare tollerare l’ansia e il senso di colpa senza evitarlo, silenziarlo o farsene sopraffare. Riguardo la difficoltà di autoregolazione del bambino ADHD, è fondamentale creare intorno al piccolo un ambiente stabile e imparare a disinnescare reazioni a sua volta disregolate che favoriranno la co-costruzione di un’atmosfera negativa. I genitori devono prendere coscienza dell’interdipendenza tra la reattività del figlio e il loro umore proprio per un discorso di ipersensibilità sensoriale. E’ essenziale che i genitori lavorino su se stessi al fine di promuovere il processo di individuazione e differenziazione, prestando massima attenzione agli schemi di fusionalità emotiva e invischiamento, interrogandosi sulle proprie modalità di interazione con il bambino.
Spesso bambini con ADHD vengono descritti come oppositivi, testardi, viziati, insolenti, “prova ad ottenere sempre ciò che vuole con reazioni esagerate”: questo accade quando l’individuo non ha la possibilità di agire liberamente e autodeterminarsi ma solo di reagire e compiacere la volontà di bisogni e desideri genitoriali ai quali i bambini ADHD provano ad aderire senza successo.
Il dissenso arriva dalla paura di essere controllati e può manifestarsi con comportamenti di passività o pigrizia (es. “più gli si mette fretta a prepararsi la mattina più rallenta i movimenti, sembra che lo faccia di proposito”) o al contrario con reazioni fuori controllo (es. urla, pianti). In entrambi i casi
l’atteggiamento oppositivo arriva da insicurezze profonde che se comprese possono evitare al genitore di sentirsi sotto scacco emotivamente o manipolato dal bambino e sostenere una posizione di curiosità e ascolto dei bisogno e dei sentimenti del figlio. In assenza di un reale ascolto è possibile che si inneschi a livello familiare una lotta di potere perché l’opposizione viene percepita
in termini di affronto all’autorità. In conclusione anche la visione dicotomica del mondo, di sé e degli altri e la difficoltà di integrazione dei vissuti deriva dall’assunzione di un immagine di sé come fallimentare. È comune che bambini e adulti con ADHD non riescano a cucire insieme le esperienze, che sembrano rimanere scomposte e frammentate (es. non posso essere sia felice che triste, non riesco a tenere insieme pregi e difetti, parti di luce e parti di ombra). Questo funzionamento “tutto o niente” dei bambini ADHD può incoraggiare i genitori ad educare con premi o punizioni che sembrano nel breve termine essere molto efficaci ma sostengono a lungo andare una visione in bianco e nero dell’ambiente e di se stessi.
In conclusione, scrive l’autore il compito più difficile che spetta ai pazienti con ADHD è imparare a trattare sé stessi con amore e compassione.
Dott.ssa Valentina Pizzichetti
Psicologa – Psicoterapeuta