
L’IMPORTANZA DELLA PRESENZA DEI PAPA’ IN SALA PARTO: SUPPORTO, CONNESSIONE E AMORE FIN DAL PRIMO ISTANTE
*Prima di proseguire con la lettura dell’articolo, ci tengo fare una premessa perchè il termine PAPA’ non venga frainteso. L’obiettivo è discutere l’importanza della presenza dei genitori in sala parto indipendentemente da come si definiscono le famiglie, e utilizzerò il termine “papà” sebbene non ci sia l’intenzione di limitarsi ad una figura maschile tradizionale.
In molte famiglie, i genitori possono essere di qualsiasi genere e orientamento sessuale, e tutti meritano di essere supportati e inclusi in questo momento speciale.
La nascita di un bambino è uno dei momenti più importanti, intensi ed emotivi nella vita di una coppia. Se per molti anni il parto è stato considerato un evento esclusivamente femminile, oggi si parla molto del ruolo del papà, fin dai primi giorni della gravidanza, durante il momento del parto e nel periodo post-partum.
In questo articolo mi soffermerò, in particolare, sull’importanza della presenza del papà in sala parto e su come in quel momento si generi supporto, connessione e amore fin dal primo istante.
E’ indiscutibile, infatti, che la presenza del papà in sala parto offra vantaggi emotivi e psicologici sia per la madre che per il bambino. Vediamoli nel dettaglio:
- Un supporto emotivo essenziale per la madre. Durante il travaglio e il parto, le madri affrontano emozioni, paure e fatiche enormi. La presenza del partner al loro fianco può avere un effetto calmante e rassicurante, riducendo l’ansia e migliorando la gestione del dolore. Il papà diventa un riferimento emotivo, una figura che la madre conosce e di cui si fida profondamente, rendendo il momento più gestibile e meno isolante.
2. Rafforzare il legame tra padre e figlio sin dal primo istante. Quando un papà è presente alla nascita del proprio figlio, l’esperienza di assistere al primo respiro del bambino crea un legame istantaneo. Il contatto visivo e la possibilità di toccare o tenere in braccio il neonato subito dopo il parto permette al papà di sviluppare fin da subito un forte legame con il figlio, stabilendo una connessione emozionale profonda che crescerà con il tempo.
3. Un momento di crescita per la coppia. Essere presenti insieme in sala parto rafforza il legame di coppia, facendo vivere un’esperienza intensa di complicità e supporto reciproco. Superare insieme un momento di grande difficoltà e gioia, crea una base solida per affrontare le sfide future della genitorialità. Il papà non è solo un osservatore, ma un partecipante attivo nel portare il bambino al mondo.
4. Sentirsi parte della nascita del proprio bambino. Molti padri riferiscono che essere presenti durante il parto li ha fatti sentire partecipi di questo evento unico, e ha dato loro la possibilità di contribuire attivamente al benessere della loro famiglia. I papà possono dare un contributo reale anche nelle piccole cose: offrire acqua, incoraggiare, aiutare la madre a trovare posizioni più confortevoli, e, semplicemente, esserci.
5. Superare le paure e creare ricordi preziosi. La sala parto può essere un luogo carico di tensione, ma è anche l’inizio di una nuova vita e di un capitolo fondamentale per una famiglia. Per il papà, essere presente significa anche affrontare le proprie paure e vivere in prima persona una trasformazione personale. Questo momento irripetibile diventa una memoria preziosa, che rafforza il loro ruolo nella famiglia.
Vien da sè che la presenza dei papà in sala parto non è solo un supporto prezioso per la madre, ma anche un’occasione unica per il padre di creare un legame con il bambino e con la compagna. Essere presenti al parto non significa solo assistere, ma vivere e contribuire all’inizio di una nuova vita insieme.
Ovviamente tutti questi aspetti sono fondamentali se pensiamo al periodo post-partum di una donna, poichè il parto non è la fine di una condizione, ma delinea l’inizio di un nuovo ruolo per i neogenitori, che non sempre viene vissuto in modo “semplice” come spesso la società vuole far credere.
Il periodo post-partum è una fase molto delicata per la neo-mamma, segnata da cambiamenti fisici, emozionali e psicologici profondi. La presenza del papà in sala parto, infatti, può avere un impatto significativo su come la madre affronta il post-partum e contribuisce a far crescere la fiducia, la serenità e la connessione emotiva.
Nella fase post-partum si sono delineati vantaggi negli aspetti emotivi nelle donne che hanno avuto il supporto del papà in sala parto.
- Maggiore sicurezza e serenità. La presenza del partner durante il parto ha un effetto rassicurante che può prolungarsi nel post-partum. Le madri che hanno condiviso con il compagno l’intensità del parto tendono a sentirsi più sicure e sostenute nei giorni successivi alla nascita. Sapere che il partner è stato lì e ha vissuto l’esperienza con loro permette alle mamme di sentirsi meno sole di fronte alle sfide emotive e fisiche dei primi giorni.
- Riduzione del rischio di depressione post-partum. Gli studi hanno evidenziato che la partecipazione attiva del partner alla nascita può aiutare a prevenire la depressione post-partum. La sensazione di essere accompagnati e comprese, unita alla certezza che il partner ha un quadro chiaro di ciò che comporta la nascita, riduce l’ansia e il senso di isolamento che spesso accompagnano le neomamme. Con un supporto empatico e presente, la madre ha maggiori probabilità di affrontare questa fase con uno stato emotivo più stabile.
- Rafforzamento del legame di coppia e maggiore comunicazione. Affrontare insieme la sala parto permette di creare una base solida per affrontare il post-partum come una squadra. Questo si traduce spesso in una comunicazione più aperta e sincera nei giorni e nei mesi successivi, poiché entrambi i partner hanno vissuto la nascita come un evento condiviso. Quando il papà è presente, i piccoli gesti e attenzioni nel post-partum diventano anche più spontanei: può essere più propenso a condividere responsabilità come il cambio dei pannolini, l’alimentazione e il supporto notturno, rafforzando l’intesa e l’equilibrio familiare.
- Sostegno attivo e comprensione delle esigenze fisiche e psicologiche della madre. Chi ha vissuto il travaglio al fianco della propria compagna comprende meglio le difficoltà fisiche che lei sta affrontando, come il dolore, la stanchezza, e i cambiamenti ormonali. Questo aiuta i papà a essere più presenti e consapevoli nel periodo post-partum, sia a livello pratico che emotivo. Con un supporto più empatico, la madre può sentirsi più compresa e meno in difficoltà nell’esprimere i propri bisogni.
- Senso di gratitudine e di fiducia reciproca. L’esperienza condivisa in sala parto spesso genera un profondo senso di gratitudine e fiducia reciproca. Molte mamme si sentono emotivamente riconnesse con il partner e apprezzano la sua presenza e il sostegno dimostrato. Questo senso di fiducia facilita il dialogo e la collaborazione nel periodo post-partum, rendendo entrambi più attenti alle reciproche esigenze e alla cura del neonato.
- Facilitazione del processo di attaccamento. Il coinvolgimento del partner dal momento della nascita aiuta la mamma a sentirsi meno “l’unica responsabile” della relazione col bambino e favorisce un attaccamento sicuro e condiviso. Sapere che il partner è emotivamente connesso e partecipe della nuova realtà familiare aiuta la mamma a dedicarsi a sé stessa e a riposare, migliorando la propria stabilità emotiva.
La presenza del papà in sala parto crea, quindi, una connessione speciale e un terreno di collaborazione emotiva che agevola la madre nel periodo post-partum. Con il sostegno emotivo del partner, molte madri si sentono più sicure, accolte e comprese, con un impatto positivo che si riflette sia sulla relazione di coppia che sull’equilibrio emotivo del nucleo familiare.
“I papà non sono accompagnatori. Quando scegliamo di andarci insieme, il papà non ci “accompagna” in sala parto: viene con noi ad accogliere il nuovo essere umano che forse avrà i suoi occhi” (Cit. Il parto positivo).
Qui di seguito riporto (in forma anonima) alcuni racconti di persone che hanno voluto condividere la loro storia e opinione.
Racconto di M.P.:
“Assistere a un parto è un’esperienza che ti cambia nel profondo. È il momento in cui il tempo sembra sospendersi, eppure ogni istante è carico di tensione, speranza e paura. La sala parto diventa uno spazio dove il mondo esterno scompare, dove esistono solo lei, con il suo corpo che si piega alla forza della natura, e tu, testimone silenzioso e impotente di qualcosa di primordiale. Lei era entrata in travaglio già da qualche ora quando io sono arrivato. Ricordo la corsa, il battito del mio cuore che si accelerava mentre attraversavo i corridoi dell’Ospedale Sant’Anna, sapendo che ogni secondo poteva essere decisivo. Quando l’ho vista, distesa sul letto della sala parto, con il viso segnato dalla fatica e dal dolore, ho capito che quelle ore sarebbero state dure. Non solo per lei, che stava affrontando una battaglia fisica e mentale, ma anche per la piccola creatura che voleva arrivare. Seduto su una sedia, guardavo, osservavo, cercavo di offrire conforto, ma il lavoro vero lo stava facendo lei. E tutto questo mi lasciava un senso di impotenza che non avevo mai provato prima. Le ore sono volate per me, ma sapevo che per lei ogni minuto era un tormento. Continuavo a chiedermi: perché una donna deve sopportare tutto questo? Viviamo in un’epoca in cui la scienza compie passi da gigante, mandiamo sonde nello spazio, esploriamo galassie lontane, eppure il parto resta un’esperienza che mette in ginocchio una donna, come se fosse rimasta ferma nel tempo, una sfida che la tecnologia non ha ancora saputo alleviare. Durante quelle ore intense in sala parto, non ho mai guardato l’orologio, né una sola volta ho preso in mano il telefonino. Il tempo sembrava essersi fermato, e non c’era nulla che potesse distogliermi da quel momento. Ero completamente immerso in ciò che stava accadendo davanti ai miei occhi, come se tutto il resto del mondo fosse sparito. Ogni respiro, ogni espressione sul suo volto, ogni movimento era qualcosa che volevo imprimere nella mia memoria per sempre. Nulla era più importante di quel momento, e non volevo che andasse perduto in distrazioni o banalità. Volevo essere presente, realmente presente, in ogni istante, perché sapevo che stavo assistendo a qualcosa di straordinario, qualcosa che avrebbe segnato per sempre la mia vita. E poi, quando il pensiero della sofferenza sembrava non avere fine, alle 18 e qualcosa, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato lui. Minuscolo, fragile, perfetto. La sala parto, per un attimo, si è riempita di una luce diversa, una gioia immensa ha travolto tutto il resto. Non potevo crederci: dopo tutte quelle ore di fatica, di attesa, e di quel dolore che sembrava insormontabile, ecco che tra le mani c’era un piccolo miracolo. Un esserino così piccolo, ma capace di riempire tutto lo spazio che fino a quel momento era stato vuoto di senso.
In quell’istante ho capito che la vita, in tutte le sue forme e complessità, è davvero un miracolo, uno che nessuna scienza o progresso potrà mai spiegare o replicare completamente.
Assistere a quel momento mi ha lasciato una gratitudine che non riuscirò mai a esprimere a parole. Lei ha affrontato una battaglia che io non potrò mai comprendere fino in fondo, ha sopportato un dolore che sembrava quasi inumano, e lo ha fatto con una forza che mi ha lasciato senza fiato. Ho capito in quelle ore quanto sia straordinaria, quanto il suo coraggio e la sua resistenza siano qualcosa che va oltre il semplice atto del dare alla luce una nuova vita.
Ogni respiro affannato, ogni sforzo, ogni istante di dolore ha costruito quel miracolo che ho avuto la fortuna di vedere nascere. La mia gratitudine per Lei è immensa, perché ha portato nel mondo una vita nuova, e l’ha fatto nonostante tutta la sofferenza, la fatica e la paura. Ero lì, seduto su quella sedia, impotente, ma il mio cuore era pieno di riconoscenza per ciò che stava facendo.
Lei non solo ha messo al mondo nostro figlio, ma mi ha mostrato cosa significhi davvero il sacrificio, la forza, e l’amore incondizionato. Non dimenticherò mai la sua determinazione, la sua lotta silenziosa e implacabile.”
Racconto di S.A.:
“Ancora prima di rimanere incinta, sapevo che non avrei voluto, in quel momento, nessuno al mio fianco oltre a mio marito e nei 9 mesi di gravidanza non ho fatto altro che confermare, a me stessa e agli altri, questa mia consapevolezza.
Prima figlia, pertanto tutto nuovo per me… mi sono documentata nei mesi, ho cercato di dare una nuova immagine al parto, non solo come evento di dolore e fatica, ma come un “viaggio” che mi avrebbe avvicinata sempre di più alla mia bimba… e devo dire di esserci riuscita. Mi sono vissuta il momento con molta serenità, pronta ad accogliere qualsiasi “cosa” accadesse perchè sarebbe stato un passo in più verso di lei. Mi sono completamente affidata al mio corpo, che ha sempre saputo “cosa fare” fin dal primo giorno della gravidanza (e molte volte lo sottovalutiamo), ma la presenza di mio marito ha fatto la differenza.
Lui era li con me e per me!
È stato sostegno emotivo, psicologico e fisico per tutto il lunghissimo travaglio e poi lo è stato anche per la mia bambina, perchè io allo stremo delle forze non me la sono sentita di prenderla in braccio nell’immediato…e questa scelta l’ho vissuta serenamente sapendo che la mia bimba era avvolta dalle braccia del suo papà.
Tutto questo ha contribuito a rafforzare il nostro rapporto e farmi sentire compresa e sostenuta anche nel periodo post partum, un periodo in cui ci si sente molto labili e vulnerabili. Sentivo che lui era nel “mio stesso team” e ho percepito la cura e le attenzioni, che mi aveva dedicato al momento del parto, ancora presenti”.
Racconto di E.T.:
“Nonostante il mio sia stato un parto meraviglioso in quanto del tutto fisiologico, rapidissimo e senza alcuna problematica/complicazione nel post, l’ho vissuto e lo ripenso ad oggi come un vero e proprio trauma.
Per trauma intendo un momento catartico, di rottura.
È stato come se il mio corpo avesse voluto segnare con un evento forte e intenso come la fine del mio percorso di gravidanza e, allo stesso tempo, dare risalto all’inizio del percorso di genitorialità che coinvolge in prima persona anche M.
È stata un’esperienza mistica e terrena (cit. Jovanotti) allo stesso tempo, a tratti violenta e straziante, sopratutto quando il mio corpo era al limite dello sforzo e la mia mente ha iniziato a vacillare e a perdersi in pensieri di cui ho provato immediatamente vergogna: voglio morire; toglietemi questa cosa dalla pancia;
Voglio fuggire da questa situazione; se l’avessi saputo non l’avrei mai fatto.
La presenza di M. durante il parto per me è stata fondamentale. Senza colpevolizzarmi, lui mi ha aiutata a trasformare questi pensieri distruttivi in pensieri positivi, a tramutarli in pensieri di forza, ricordandomi costantemente che il dolore fisico sarebbe cessato e che stavo facendo un ottimo lavoro.
Il suo supporto fisico e psicologico non sono riusciti ad eliminare il dolore fisico ma hanno alleviato le mie preoccupazioni e mi hanno aiutata a sgomberare la mente, a lasciarmi andare e a sentirmi scura in un momento di grande fragilità, consapevole che, per qualunque altra cosa diversa dall’atto di “partorire”, lui avrebbe agito per me. Sebbene impotente di fronte al mio dolore corporeo, vederlo e sentirlo al mio fianco mi ricordava che l’impresa che stavo affrontando non era soltanto mia. Sento c he aver condiviso con lui un momento così intimo e speciale ci ha legati in un modo particolare per sempre.”
Racconto di S.M.:
“Avevo letto tanto sul parto, avevamo anche fatto un corso pre-parto con un’ostetrica privata. Ma la verità è che nulla ti prepara veramente a tutto ciò che ti aspetta durante il travaglio e il parto. Ore di ansia. Ma quando questa è condivisa sicuramente è più facile da sopportare. Mia moglie continua tuttora a dire che io le sia stato di grande supporto. Io mi sono sentito inutile tutto il tempo. Vedi tutta quella sofferenza e puoi fare ben poco, aumentava solo la mia frustrazione. Come può il corpo umano sopportare tutto ciò non l’ho ancora capito. Dolore atroce che ti spinge a vomitare il nulla che hai nello stomaco. Un mistero. Ed io ero lì, a guardare tutto questo. Volevo aiutarla, ci provavo. Cercavo di incoraggiarla, di farmi sentire al suo fianco, ma mi sembrava tutto inutile. Mi sentivo impotente. Quando poi é nata mia figlia, mia moglie era stremata. Ho visto mia figlia. Era blu, neanche un gemito. Ero terrorizzato ma non volevo che, dopo quello sforzo inimmaginabile, mia moglie si preoccupasse. Le dicevo: “va tutto bene…”. Intanto morivo dentro. Poi l’ho sentita. Penso sia stato il minuto più lungo della mia vita! Mi hanno poi spiegato che era solo un momento di adattamento al nuovo habitat. Tremavo di gioia. Ho avuto la fortuna di fare il contatto pelle a pelle. Non potevo credere che qualcosa di così bello potesse esistere ed era lì tra le mie braccia. Mia moglie sul lettino della sala parto e rideva con la ginecologa e le ostetriche mentre la suturavano. Ero troppo felice per riflettere. Poi a mente fredda ho pensato: “ Non riesco a spiegarmi come possa aver sopportato tutto ciò, ma addirittura ridere… é surreale…”. Credo che sia stato l’amore. L’amore batte tutto il resto.”
Dott.ssa Sonia Allegro
Psicologa – Psicoterapeuta










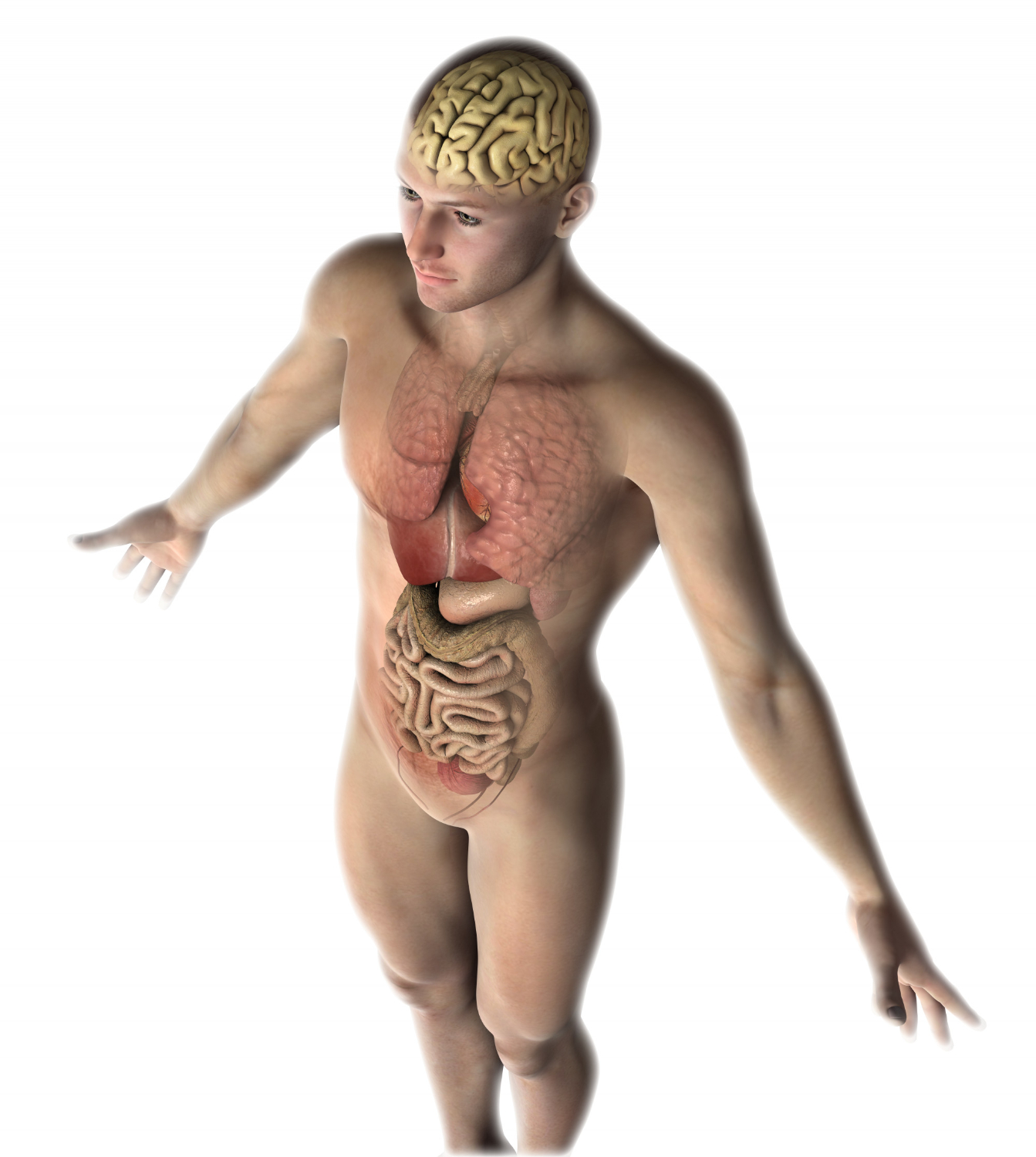
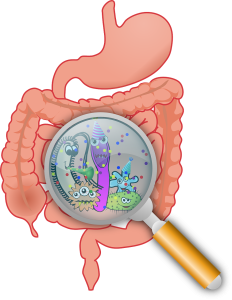 Il microbiota, detto più comunemente flora intestinale, ha proprio la funzione di intervenire in questo processo, ostacolando, ad esempio, il proliferare di agenti dannosi per la nostra salute. Inoltre, il microbiota intestinale è capace di comunicare e interagire con il primo cervello. Basti pensare che, quando mangiamo un cibo gustoso, l’intestino attiva i suoi recettori aumentando la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore deputato alla felicità e a sensazioni di benessere. La serotonina è
Il microbiota, detto più comunemente flora intestinale, ha proprio la funzione di intervenire in questo processo, ostacolando, ad esempio, il proliferare di agenti dannosi per la nostra salute. Inoltre, il microbiota intestinale è capace di comunicare e interagire con il primo cervello. Basti pensare che, quando mangiamo un cibo gustoso, l’intestino attiva i suoi recettori aumentando la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore deputato alla felicità e a sensazioni di benessere. La serotonina è 